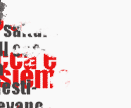|
|
|
04 Marzo 2013
Possiamo fare a meno dei partiti? Succede di già |

 Daniel Cohn-Bendit lascia la politica dei partiti. Il ragazzo anarchico che partendo da Nanterre infiammò le barricate del Maggio francese, l’ebreo tedesco espulso dalla Francia che fece urlare nei cortei del 1968 «Nous sommes tous juif allemandes», il fondatore, con Joschka Fischer, del movimento dei Grunen, i Verdi tedeschi, i Realo pragmatici che hanno avuto un ruolo importante nella politica della Germania degli ultimi venti anni, l’europarlamentare che si è battuto per difendere e diffondere i temi ecologici in Europa, non si ricandiderà alle elezioni. Dipende dai postumi della sua lotta contro un tumore alla tiroide che lo ha prostrato, ma soprattutto da una serie di convincimenti maturati nel tempo che ha condensato in un piccolo libro — una cinquantina di pagine — appena arrivato in libreria: Pour supprimer les partis politiques!? Réflexions d’un apatride sans parti, Editions Indigènes, che è insieme una rapida autobiografia e un pamphlet contro il partito politico — qualsiasi, possiamo supporre anche il “suo”, dei Verdi —, questo artificio che dalla rivoluzione giacobina passando per la rivoluzione d’Ottobre e le riflessioni di Weber si è incistato nel continente — a me sembra che l’esperienza americana sia differente. Qui, ci interessa il pamphlet. Daniel Cohn-Bendit lascia la politica dei partiti. Il ragazzo anarchico che partendo da Nanterre infiammò le barricate del Maggio francese, l’ebreo tedesco espulso dalla Francia che fece urlare nei cortei del 1968 «Nous sommes tous juif allemandes», il fondatore, con Joschka Fischer, del movimento dei Grunen, i Verdi tedeschi, i Realo pragmatici che hanno avuto un ruolo importante nella politica della Germania degli ultimi venti anni, l’europarlamentare che si è battuto per difendere e diffondere i temi ecologici in Europa, non si ricandiderà alle elezioni. Dipende dai postumi della sua lotta contro un tumore alla tiroide che lo ha prostrato, ma soprattutto da una serie di convincimenti maturati nel tempo che ha condensato in un piccolo libro — una cinquantina di pagine — appena arrivato in libreria: Pour supprimer les partis politiques!? Réflexions d’un apatride sans parti, Editions Indigènes, che è insieme una rapida autobiografia e un pamphlet contro il partito politico — qualsiasi, possiamo supporre anche il “suo”, dei Verdi —, questo artificio che dalla rivoluzione giacobina passando per la rivoluzione d’Ottobre e le riflessioni di Weber si è incistato nel continente — a me sembra che l’esperienza americana sia differente. Qui, ci interessa il pamphlet.
Scrive Cohn-Bendit, che con solennità si dichiara «simultanément contre la dictature du prolétariat et contre la dictature du capitalisme», di aver maturato molto presto il convincimento «qu’un parti ne pouvait supporter la dissidence. La matrice idéologique d’un parti, c’est en fait une armure». È di fatto una armatura. Impenetrabile. Cohn-Bendit, che non ha alcuna intenzione di abbandonare la scena pubblica, pensa che siano necessarie piuttosto forme di cooperazione, di associazione fra cittadini per portare avanti proposte, proteste e per conquistare «l’autonomie».
Per quanto possa essere interessante, e lo è, per quello che una biografia può raccontare di un periodo storico e del suo lascito, la dichiarazione di intenti di Cohn-Bendit sembra più una presa d’atto che un programma. Voglio dire: i partiti politici sono già soppressi, c’è poco da interrogarsene e agitarsene in merito.
Non credo che la disaffezione quando non l’ostilità ai partiti politici — di cui l’Europa sta sperimentando varie forme, un po’ dovunque, dalla crescita dell’astensione al proliferare di movimenti apertamente contro i partiti alla rinascita di movimenti identitari, territoriali— sia solo una questione “sociale”, dipenda cioè esclusivamente dalla crisi delle ideologie e degli orientamenti che hanno caratterizzato il Novecento. Credo piuttosto che la crisi dei partiti politici debba essere ricondotta alla crisi dell’universalità e alle modificazioni produttive. L’una e l’altra — universalità e produzione — sono le strutture della rappresentanza politica, della cittadinanza, almeno per la nostra storia europea, mentre invece è determinante nella cultura anglosassone il criterio No taxation without representation, il prelievo fiscale in cambio di utilità, cioè il rapporto diretto tra cittadino e governo. Non so se c’entri qualcosa la storia quacchera, quella delle colonie e la disobbedienza civile di Thoreau, ma il rapporto tra cittadino e governo nella storia americana è più diretto, proprio come quello tra uomo e Dio, mentre la storia nostra è intessuta di mediazioni, di corpi intermedi, di “chiese” tra cittadino e governo come tra uomo e Dio.
La storia europea dal Seicento al Novecento è storia dello Stato, senza lo Stato — il suo monopolio della forza, il patto di obbedienza in cambio di sicurezza — saremmo condannati alla frantumazione, all’implosione, alla sopraffazione, alla guerra intestina. È in questa “visione” che sta la centralità dello Stato e trova ragione lo strumento del partito politico per conquistarlo o per mantenerne il comando. La storia dello Stato del Novecento è stata storia di conflitti tra partiti del proletariato e partiti della borghesia, tra partito del capitale e partito del lavoro. Ed è stata una storia grande. Era qui — capitale e lavoro — la materialità del partito politico. La materialità del conflitto e del compromesso.
Si può ancora dire oggi che esista un partito del capitale, il “comitato d’affari della borghesia”? E, di converso, si può ancora dire che esista un partito del lavoro? Sembra piuttosto che capitale e lavoro siano senza un partito “proprio”, sembra anzi che ne facciano bellamente o mestamente a meno. Il capitale, inoltre, può fare a meno dello Stato, dello Stato-nazione, ha dismesso lo Stato, e per questa via il lavoro [il lavoro che produce] non può più usare lo Stato ai propri fini. Lo Stato è un involucro vuoto, o meglio un apparato privo di senso e di scopo — guardate com’è carta straccia la nostra Costituzione —, tranne la propria riproduzione. In questo “parassitismo” è rimasto intrappolato il partito politico.
I processi multitudinari — la scomposizione della classe operaia dalla sua unicità in mille prestazioni d’opera, una volta che la fabbrica e il suo modello di produzione non è stato più il parametro delle relazioni sociali — hanno investito in pieno la “borghesia”, frammentandone a sua volta la sua unicità di comportamento, di status. Il comando dei processi come l’investitura di una missione sono passati direttamente alle nuove élite. Transnazionali come il denaro. L’atomizzazione, l’individualizzazione non sono stati processi che hanno colpito solo il “proletariato”, ma anche le classi medie. Per un verso si è tutti “ceto medio”, per un altro si è sempre tutti a rischio di scivolare dall’inclusione verso l’esclusione.
Il fatto è che a questo sradicamento della politica non è seguito un processo di cittadinanza, una secolarizzazione rivestita di diritti dalla precedente appartenenza ecclesiale, tutta ideologica e di fede, per gli uni, proiettata sul futuro, tutta di interessi, per gli altri, proiettata sul presente. Perché nel frattempo lo Stato, il “pubblico”, è stato sistematicamente smantellato in tappe di privatizzazione. E senza il “pubblico”, quello scopo che proiettava le parti verso un interesse universale, ogni partito politico si è privatizzato [c’è chi lo ha fatto con più determinazione e consapevolezza, ma non era un’anomalia].
È vero, il “brand” — come altro si può definire oggi una bandiera ideologica — resiste, perché siamo impastati anche di questo, di miti e nostalgie. Però, questo tesoretto non è esclusivo, si può fare e disfare un partito politico in tre mesi: per dire da noi, a destra hanno messo su “Fratelli d’Italia, al centro “Scelta civica”, a sinistra “Rivoluzione civile”. Sono taxi per campagne elettorali, durano quel tempo lì.
Qui dunque stiamo: la politica, intesa come costruzione di un consenso e esercizio della sua forza non è certo scomparsa. Anzi, cresce la consapevolezza di questa necessità. È sui territori, nella vita quotidiana che si sperimentano forme nuove di associazione tra liberi e uguali. I partiti, tutt’al più servono per i periodi elettorali: anche i cittadini li usano come taxi, perché è chiaro a tutti che le decisioni non sempre si riesce a renderle vincolanti sul territorio. Almeno finché non prenderà forma l’idea che forse quello che si riesce a fare sul territorio non si possa trasporre anche a livelli più ampi.
Comincia già a succedere. Con buona pace di Cohn-Bendit.
Nicotera, 4 marzo 2013 |
 |
| [torna
su] |
 |
|
|