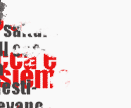|
|
|
01 Giugno 2013
Dalla forma di formaggio alle forme di cultura, e ritorno |

 «Non era senza un vero dispiacere che per l’addietro, sostando davanti al negozio dei principali salumieri delle nostre città, non si potesse scorgere alcun formaggio di lusso che portasse un nome italiano. Fui il primo che, dopo lunga esperienza, riuscii a soppiantare l’importazione estera, mettendo in commercio i miei formaggi di lusso, uso Francesi» [1]. Parole di Egidio Galbani, lombardo, l’inventore del Formaggio del Bel Paese. «Non era senza un vero dispiacere che per l’addietro, sostando davanti al negozio dei principali salumieri delle nostre città, non si potesse scorgere alcun formaggio di lusso che portasse un nome italiano. Fui il primo che, dopo lunga esperienza, riuscii a soppiantare l’importazione estera, mettendo in commercio i miei formaggi di lusso, uso Francesi» [1]. Parole di Egidio Galbani, lombardo, l’inventore del Formaggio del Bel Paese.
Con spirito che potremmo definire caseario–patriottico Egidio Galbani agli inizi del Novecento, in un tempo in cui i formaggi erano ancora perlopiù artigianali — la Valsassina è la “terra” da cui vengono le famiglie Cademartori, Ciresa, Galbani, Locatelli, Invernizzi, Mauri — e la cui distribuzione era limitata all’ambito locale, confeziona un prodotto per la tavola fabbricato in uno stabilimento industriale, appoggiandosi alla rete ferroviaria che andava irrobustendosi e corroborandola con una propria distribuzione attraverso furgoncini, e sostenendolo con un’innovativa campagna pubblicitaria: un successo enorme durato un secolo, oggi la Galbani è “straniera” come tanti altri prodotti italiani, della francese Lactalis dal 2006 [gli “uso Francesi” si sono riappropriati dell’imitazione italiana]. Davvero un grande spirito imprenditoriale, un “capitano coraggioso”.
Il vero colpo di genio di Galbani fu il confezionamento, quello che oggi chiamiamo packaging — qui non si parla di vermi [2] e di metodologia della storia. Sulla rotonda forma di formaggio, venne applicata un’etichetta con la cartina dell’Italia — il Bel Paese, appunto — e la faccia austera e rassicurante di un signore. Che non era l’Egidio Galbani stesso, ma l’abate Stoppani.
A 24 anni, lecchese, nel 1848, anno della sua consacrazione a sacerdote, Stoppani è tra i seminaristi sulle barricate delle Cinque Giornate a Milano, e dietro le piccole mongolfiere che si sollevano per annunciare la rivoluzione in città e chiedere aiuto alle campagne c’è anche la sua formazione scientifica. Rosminiano e manzoniano, naturalista, professore di Geologia a Pavia nel ’67, passa poi al Politecnico di Milano e quindici anni dopo diventa direttore del Museo Civico di scienze naturali. È anche fondatore della sezione milanese del Club Alpino Italiano. Il suo libro, Il Bel Paese. Conversazioni sulle bellezze naturali, la geologia e la geografia fisica d’Italia, è della metà degli anni Settanta, e racconta di un viaggio che partendo dalla sua Lombardia lo porta giù «a balzelloni» fino all’Etna. Il racconto di questo viaggio naturalistico è rivolto «agli institutori», con l’intento di bilanciare le belle lettere attraverso la sensibilità tecnico–scientifica. Il dispositivo fabulatorio è quello delle narrazioni a veglia: ventinove serate di un lungo e freddo inverno lombardo, in cui l’io narrante racconta a dei ragazzini per ogni serata un luogo e le sue meraviglie [per dire: le prime sette sono dedicate alle Alpi, l’VIII alle Prealpi, dalla XXIV alla XXVII al Vesuvio e le ultime due, la XXVIII e la XXIX all’Etna, tutti luoghi davvero visitati dallo Stoppani di persona] [3].
Anche lo Stoppani, come il Galbani, è animato da italianità: «Vedete – dice rivolto ai ragazzi che lo ascoltano –, voi siete come siamo noi italiani in generale. Il bello, il buono, l’utile, tutto ci deve venire d’oltremare e d’oltre monti. Non dico che noi dobbiamo credere di posseder tutto, e di poter fare senza del molto che ci può venire altronde. Sarebbe stoltezza […] Ma ciascuno deve anzi tutto fare i conti in casa propria: ché il cercare l’altrui, mentre si possiede del proprio, è vergognosa mendicità».
A rigor di logica, se faccia da letterato aveva da esserci sulla forma di un formaggio dal nome Bel Paese doveva essere di Dante: «Ahi Pisa, vituperio de le genti / del bel paese là dove ‘l sì suona» [4], o del Petrarca: «il bel paese / ch’Appennin parte, e ‘l mar circonda e l’Alpe» [5], che avevano inventato la locuzione. Credo che nella scelta di Galbani verso lo Stoppani abbia giocato una declinazione “tecnica”, una rivendicazione industriale delle lettere, una considerazione solida delle cose piuttosto che effuse di allori. Inoltre, quando Galbani decide questa nominazione colta d’un formaggio, il libro dello Stoppani aveva venduto centinaia di migliaia di copie e era arrivato alla 60° edizione: un successo strepitoso durato decenni. Un vero libro di formazione “nazionale”. Un veicolo commerciale di grande popolarità, quindi. Il target — diremmo oggi — di Galbani per il suo formaggio era la stessa platea di lettori dello Stoppani: il ceto medio che si affacciava contemporaneamente alla cultura e ai formaggi, forse entrambe le cose, per gli italiani del tempo, «di lusso, uso Francesi». Oltre a essere la “traduzione” di un formaggio dal francese all’italiano, la faccia dell’autore del Bel Paese su un formaggio che si chiama Bel Paese gioca, forse inconsapevolmente, sulla natura intertestuale del linguaggio con una mise en abyme [nella critica letteraria, la mise en abyme indica un particolare tipo di “storia nella storia”, in cui la storia raccontata — livello basso, il formaggio — può essere usata per riassumere o racchiudere alcuni aspetti della storia che la incornicia — livello alto, il libro].
Un formaggio futurista?
Per quanto si sarebbe preso del “passatista” da Marinetti, a modo suo Galbani col formaggio letterato apre forse la strada al futurismo che con la pubblicità industriale ebbe un rapporto passionale e profondo. Non solo Depero fondò nel 1919 la Casa d’arte Futurista, che funzionava da agenzia pubblicitaria, ma collaborò a lungo con la Campari per cui creò una serie di importanti annunci, un progetto di Padiglione e nel 1926 portò alla Biennale di Venezia un dipinto intitolato Squisito al Selz; Marcello Dudovich collaborò per circa venti anni con i Grandi Magazzini Mele di Napoli che avevano importato e riprodotto in Italia l’esperienza dei grandi magazzini Lafayette [ancora «gli uso Francesi»], lavorò per la marca Zenit e instaurò una proficua collaborazione con i magazzini La Rinascente [nome inventato dal Grande Vate D’Annunzio]; la AEG pubblicizzò una lampadina con uno slogan marinettiano: «Uccidiamo il chiaro di luna». Molti altri — tra cui Nicolaï Diulgheroff, Prampolini, Farfa, Giacomo Balla, Bruno Munari — produssero straordinari oggetti pubblicitari [6].
A prima vista, qui ancora siamo in quel rapporto fra arte e pubblicità “ottocentesco”, quello di Aristide Bruant che si faceva dipingere i cartelloni da Toulouse Lautrec; insomma, nonostante ci siano delle ragioni, come è stato detto, nel definire questa disposizione futurista alla pubblicità come un canto, un’ode, «una celebrazione dell’epos industriale» [7], sembrerebbe ancora un rapporto da belle époque, quello proprio della nascita del poster, de l’affiche. Oggi, ne abbiamo degli esempi tecnologicamente ammodernati di questa logica, che so, Wim Wenders che presenta a Berlino lo smartphone Galaxy Note 10.1 della Nokia, con un piccolo cortometraggio chiamato Recreate Berlin, un’opera girata e montata in cinque giorni tramite proprio quell’apparecchio. Si chiama product placement, adesso: vi si sono cimentati tra i più celebrati registi di cinema, da David Lynch a Martin Scorsese a Woody Allen, come peraltro tra i più apprezzati registi italiani [Giuseppe Tornatore, Gabriele Salvatores, Gabriele Muccino, Ferzan Ozpeteck, solo per fare qualche nome]. Anche Federico Fellini girò dei famosi spot per Barilla e Campari.
Il futurismo però — il cui Manifesto, com’è noto, fu pubblicato sulla prima pagina de «Le Figaro», il 20 febbraio del 1909, un po’ all’«uso francese», insomma — era più ambizioso. Nel Numero unico futurista Campari del 1931 Depero pubblica il manifesto Il futurismo e l’arte pubblicitaria con una rivendicazione di dignità artistica totale: «Tutta l’arte dei secoli scorsi è improntata a scopo pubblicitario […] l’arte dell’avvenire sarà potentemente pubblicitaria […] Arte fatalmente moderna – arte fatalmente audace – arte fatalmente pagata – arte fatalmente vissuta». Depero produsse in proprio mobili, stoffe, perfino gilet [pardon, panciotti] futuristi.
Non solo Marinetti contribuisce a una poesia pubblicitaria e industriale, con i suoi libri scritti per la Snia Viscosa, Il poema del vestito di latte del 1927 – grafica di Munari – per “cantare” il lanital, una fibra ottenuta autarchicamente dalla caseina [lo spirito caseario–patriottico ritorna, come un’ossessione], e Il poema di Torre Viscosa del 1938: «Tutto è deciso nulla salvò né avrebbe mai salvato gli eroici canneti devoti al languore / Eccole infornate costrette sul sistematico andare senza fine andare del trasportatore a nastro / di gomma funereo / Ingoiamento e digrignare delle tagliere tronfio masticare metallico / Fiato fiato fiato e tutto s’innalza in un immenso fiato nelle bocche prone degli alti silos / Poi giù trituratissima miscela stridulante d’agonie giù nei bollitori rossi ostentati ventri d’acciaio / nella trasparente cattedralica torre / Colori odori rumori di insolenza guerriera». Anche un poeta come Giovanni Gerbino arriva a stilare un suo manifesto della poesia pubblicitaria dove afferma: «Per poesia pubblicitaria non deve intendersi una filastrocca di parole gettate giù obbligatoriamente per cantare con voce lugubre le qualità d’un prodotto industriale o commerciale vergognandosi, infine, d’assumersene la paternità, com’è d’uso, con evidente malafede, in certi rimaioli passatisti, ma vera e propria poesia nel senso più alto della parola […] Esaltare un prodotto industriale o commerciale con lo stesso stato d’animo con sui si esaltano gli occhi d’una donna».
Bisognerà aspettare la pop art per avere questo stesso grado di consapevolezza del rapporto tra cultura e merce, rovesciandolo. Ecco allora apparire, sulle tele degli artisti pop, i simboli delle industrie più note dell’epoca: Coca Cola, Brillo, Campbell ecc., quegli stessi logo che scandivano la vita quotidiana. La pubblicità stessa di un oggetto diventa opera d’arte [per citare qualcosa: Jasper Johns, Painted Bronze (Ballantine Ale Cans), 1960; Andy Wahrol, Close Cover before Striking (Pepsi Cola), 1962; Richard Hamilton, Toaster, 1967].
Fosse stato in Italia, c’è da scommetterci che Wahrol invece della lattina Campbell’s Tomato Soup avrebbe dipinto la forma di Formaggio del Bel Paese di Galbani. Egidio Galbani con la sua forma di formaggio letterato fu perciò un precursore della pop art? O piuttosto un precursore della culturalizzazione pop dell’impresa?
Autarchia culturale e esterofilia
Nel gennaio 1816 esce su «Biblioteca Italiana» il breve saggio di Madame Anne Louise Germaine de Staël, Sulla maniera e la utilità delle Traduzioni, che interviene sulla crisi della letteratura italiana additandone le cause nel neoclassicismo e tanta influenza avrà sulle lettere e i letterati italiani del tempo, fino a dare abbrivio alla svolta del Romanticismo. Scrive la de Staël: «Dovrebbero a mio avviso gl’Italiani tradurre diligentemente assai delle recenti poesie inglesi e tedesche; onde mostrare qualche novità a’ loro cittadini, i quali per lo più stanno contenti all’antica mitologia: né pensano che quelle favole sono da un pezzo anticate, anzi il resto d’Europa le ha già abbandonate e dimentiche. Perciò gl’intelletti della bella Italia, se amano di non giacere oziosi, rivolgano spesso l’attenzione al di là dall’Alpi, non dico per vestire le fogge straniere, ma per conoscerle; non per diventare imitatori, ma per uscire di quelle usanze viete, le quali durano nella letteratura come nelle compagnie i complimenti, a pregiudizio della naturale schiettezza» [8].
Esterofilia culturale [anglofila, francofila, germanofila] e autarchia intellettuale si sono succedute e altalenate spesso da allora nel dibattito culturale italiano. Gramsci scrisse pagine belle e profonde in merito in Letteratura e vita nazionale [9]. Siamo stati anglofili: le diciotto edizioni di Self Help, di Samuel Smiles, una sorta di manuale dell’uomo che si fa da sé attraverso la “religione del lavoro”, peana dell’imprenditore dal carattere volitivo e concreto, e non piuttosto amorale e accidioso come i meridionali e i latini, nel 1889 avevano venduto 75.000 copie, un bestseller. Gli inglesi erano considerati «senza dubbio il primo popolo della terra» e per lodare l’industriosità dei piemontesi si diceva di loro — anche il D’Azeglio, lo diceva — che fossero «inglesi italianizzati». Non saremmo mai stati dei veri capitalisti, insomma, e non avremmo avuto chance nella competizione per le colonie, se non li avessimo imitati. Siamo stati germanofili: dopo la vittoria prussiana del 1870 sulla Francia, Francesco De Sanctis, ministro dell’Educazione, richiamandosi ai notevoli risultati ottenuti dalla Germania che aveva dedicato molte risorse all’educazione fisica, cominciò a promuovere una educazione più “virile”. Lo storico Pasquale Villari parlò di «una grande vittoria dei popoli germanici e protestanti sui popoli latini e cattolici, i quali sembrano per tutto essere in decadenza» e Crispi, che ammirava Bismarck, promosse una «Associazione nazionale per l’educazione fisica e militare del popolo», mentre Carducci inveiva poetando contro quel «vecchio popolo di frati, briganti, ciceroni e cicisbei» che gli italiani non avevano mai smesso di essere. Siamo stati francofili: il francese Alfred Fouillée, agli inizi del Novecento, dopo un lungo e dettagliato esame delle caratteristiche psicologiche dei principali popoli europei, concluse che non c’era alcuna evidenza scientifica che provasse la degenerazione delle popolazioni neolatine e la loro inferiorità nei confronti degli anglosassoni. E d’altronde, la Francia non aveva dispiegato il tipo migliore di colonialismo, più sensibile degli altri ai diritti dei colonizzati? I paladini del colonialismo italiano fecero proprie queste considerazioni, con gran seguito di popolo e di letterati [10].
Siamo stati autarchici [«In alto viaggiare viaggiare senza fine la nuova costellazione le cui stelle formano la parola / AUTARCHIA», F.T. Marinetti»], perlopiù ricalcando lo Stoppani [«Ma ciascuno deve anzi tutto fare i conti in casa propria: ché il cercare l’altrui, mentre si possiede del proprio, è vergognosa mendicità»]. In genere, però, ci siamo attestati, sui caratteri delle varie lingue europee [e delle culture e dei rispettivi popoli], su quanto già scriveva il Muratori nel suo Della perfetta poesia italiana: di Carlo V si raccontava come egli solesse dire che «s’il voulait parler aux hommes, il parleroit françois; s’il voulait parler a son cheval, il parleroit allemand; s’il voulait parler aux Dames, il parleroit italien et s’il voulait parler à Dieu, il parleroit espagnol» [11].
È questa, un’idea d’Europa dura a morire chez nous. È con l’America che cambiano davvero le cose.
Americana e le traduzioni di Vittorini
Americana è un’antologia che raccoglie testi di trentatré narratori americani, dal primo Ottocento fino agli anni Trenta, progettata e organizzata da Vittorini negli anni 1939-40. I vari autori sono inseriti in nove periodizzazioni storico-critiche [Le origini; I classici; Nascita della leggenda; La letteratura della borghesia; Leggenda e verismo; Il rivolgimento delle forme; Eccentrici, una parentesi; Storia contemporanea; La nuova leggenda], presentate da Vittorini con analisi originali. Inoltre ogni autore è introdotto da una brevissima scheda che ne riepiloga l’attività letteraria. Le traduzioni dei testi sono opera di vari autori, tra cui Vittorini stesso, Montale, Pavese, Moravia.
È ormai sedimentata una vulgata per cui l’intento di Vittorini era far conoscere la letteratura americana in Italia, dove il fascismo aveva quasi imposto una chiusura culturale verso le letterature straniere, come una sfida di libertà contro il regime. La mia personalissima idea è che la cosa sia più complessa e che Vittorini si muovesse su una sottilissima striscia di confine e contasse anche sulla simpatia che dagli Stati uniti si riversava sull’Italia e sulla curiosità di Mussolini verso l’America — la complessità, cioè, non è data solo dalla personalità di Vittorini ma dal rapporto fra il fascismo e gli Stati uniti sino all’ingresso nel conflitto mondiale. Il mito di un mondo nuovo, fatto di voci nuove e forze nuove, che esprimeva “furore”, la condizione di “vitalità” e di “ferocia” che pervade quegli autori, espressione di un vivere forte e primitivo in un mondo tutto da costruire, potevano essere tutti temi che trovavano eco in una certa mitopoiesi del fascismo.
La prima edizione di Americana [1940] fu bloccata dalla censura fascista, che per fare uscire l’opera impose al suo editore Bompiani di eliminare le note scritte da Vittorini e di introdurre una presentazione di Emilio Cecchi, che dava un’interpretazione molto limitativa della letteratura americana, con giudizi negativi su parecchi autori, a esempio Hemingway, e complessivamente sugli Stati uniti. Ma la prima edizione di Furore di Steinbeck è del 1941 [editore, sempre Bompiani], e considerando che il romanzo fosse uscito nel ’39 e avesse vinto il Pulitzer nel ’40 e nello stesso anno Ford ci avesse fatto il film, si può dire che si andava quasi più veloci allora, nelle traduzioni.
Le traduzioni di Vittorini sono spesso poco aderenti, per usare un eufemismo, al testo originale. Voglio riportare un esempio, tratto dal racconto The Gambler, the Nun and the Radio, ovvero Il giocatore d’azzardo, la monaca e la radio che diventa nelle mani di Vittorini Monaca e messicani, la radio. Già nel titolo, il gambler, un messicano, diventa una pluralità di giocatori d’azzardo, anzi di messicani — la monaca, invece, rimane singola.
But Seattle he came to know very well, the taxicab company with the big white cabs (each cab equipped with radio itself) he rode in every night out to the roadhouse on the Canadian side where he followed the course of parties by the musical selections they phoned for. He lived in Seattle from two o'clock on, each night, hearing the pieces that all the different people asked for, and it was as real as Minneapolis, where the revellers left their beds each morning to make that trip down to the studio. Mr Frazer grew very fond of Seattle, Washington.
«Ma Seattle la conosceva bene, la percorreva ogni notte in un taxi bianco che aveva la radio e andava lungo il mare. Viveva a Seattle dalle due in poi, ogni notte, e Seattle era per lui reale come Minneapolis dove i Revelers lasciavano il letto ogni mattina per recarsi allo studio in tram, prima dell’alba. Egli voleva un gran bene a Seattle, sull’Atlantico».
I tagli di Vittorini, che aveva studiato l’inglese da sé partendo dal Robinson Crusoe di Defoe e scrivendo sopra ogni parola del testo quella italiana corrispondente, sono numerosissimi e riguardano sia singoli termini che frasi intere — altro che minimalismo di Carver “prodotto” del suo editor Gordon Lish. Il termine “ballrooms” viene totalmente omesso; vengono eliminate due righe del testo americano [out to the roadhouse on the Canadian side where he followed the course of parties by the musical selections they phoned for]; “Canadian side”, letteralmente “confine sul Canada”, “confine canadese”, viene reso con “andava lungo il mare”; il termine “tram” viene aggiunto probabilmente per venire incontro a un’idea della città americana del lettore italiano; e i revellers [festaioli, modaioli] diventano Revelers, come fosse un gruppo jazz. Anche “Seattle, Washington” viene cambiato in “Seattle, sull’Atlantico”, quando in realtà si trova sul Pacifico [12].
Straordinario, Vittorini reinventò l’America per gli italiani, la rigirò a specchio persino sui suoi confini oceanici. Siamo con ogni evidenza oltre l’altalena fra autarchia e esterofilia [davvero, non so se sia il caso di parlare qui di anglofilia]: una autonomia di scrittura nel tradurre. Chissà cosa ne avrebbe detto la de Staël. Probabilmente avrebbe approvato.
Recentemente [13], Antonio D’Orrico ha confrontato due traduzioni dell’incipit del Grande Gatsby di Scott Fitzgerald, un longseller che ha avuto ulteriore impennata dal film di quest’anno, affiancandole, per sottolineare inorridito come da un libro a 0,99 centesimi [Fitzgerald è ormai fuori diritti] — cheap nel costo ma anche nella traduzione — c’è da aspettarsi ben poco, e che bisogna invece affidarsi alla grande distribuzione e alla qualità delle loro traduzioni. Ecco il famoso incipit: «In my younger and more vulnerable years my father gave me some advice that I’ve been turning over in my mind ever since». Questa è versione della Pivano [appena riproposta negli Oscar] che manda in deliquio D’Orrico: «Negli anni più vulnerabili della mia giovinezza, mio padre mi diede un consiglio che non mi è mai più uscito di mente». E ecco invece la traduzione da 0,99 centesimi che inorridisce D’Orrico: «Quand’ero più giovane e indifeso, mio padre mi ha dato un consiglio che ho fatto mio da allora». A me non sembra male, e mi chiedo: non è invece che da qualche parte nascosta si vada covando un nuovo Vittorini?
Certo, la Pivano è un monumento nazionale delle traduzioni, oltre che essere stata un veicolo straordinario di attenzione, sensibilità e conoscenza nel portare qui da noi fenomeni e autori sempre nuovi di letteratura americana, dalla Beat generation fino a Jay McInerney e Bret Easton Ellis passando per Henry Miller e Charles Bukowski. Però, qualcosa dev’essersi rotto nel gran flusso di letteratura americana se oggi si scrive così: «Senza dubbio, la letteratura italiana deve aprirsi a orizzonti diversi, guardare al futuro, creare se stessa, autofondandosi, un pubblico a venire… Immettere la letteratura italiana in un’orbita globale significa dover leggere solo DeLillo, Pynchon, Philip Dick, Stephen King, ecc.? Oppure significa riconoscere che Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Tasso, ecc. vanno letti in una prospettiva diversa, verificando come oggi, di fronte alla modernità, interagiscono con i lettori e la letteratura?» [14] Sembra — calco un po’ la mano, eh — una Exhortatio ad capessendam Italiam in libertatemque a barbaris vindicandam [Esortazione a pigliare l’Italia e liberarla dai barbari], del Machiavelli [cap. XXVI del Principe, quello che si chiude con l’invocazione del Petrarca, c’è una circolarità di citazioni, mi rendo conto: «vertú contra furore / prenderà l’arme, et fia ’l combatter corto: / ché l’antiquo valore / ne gli italici cor’ non è anchor morto», All’Italia].
Però, qualcosa dev’essersi rotto nella predominanza anglofona se alla decisione del rettore del Politecnico di Milano che i corsi post laurea vengano fatti esclusivamente in inglese 234 professori e ricercatori dell’Istituto si sono espressi contro, ricorrendo al Tar e firmando un documento – intitolato “Appello a difesa della libertà di insegnamento” – in cui la si considera illegittima perché, tra l’altro, andrebbe contro l’articolo 271 del Regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592 [15]. Il provvedimento, in pieno regime fascista, stabiliva che: «La lingua italiana è lingua ufficiale dell’insegnamento e degli esami in tutti gli stabilimenti universitari». Il decreto non è mai stato abrogato formalmente. L’autarchia, come uno spettro, continua a aggirarsi fra noi. O, quanto meno, nelle aule universitarie.
I due «Il Politecnico» e «Il Menabò»
Qui comunque Vittorini ci interessa anche per «Il Politecnico», la rivista prima settimanale poi mensile da lui fondata e pubblicata a Milano dal settembre 1945 al dicembre 1947.
«Il Politecnico» era stata la rivista fondata da Carlo Cattaneo e pubblicata in due periodi, dal gennaio 1839 fino al 1844 e poi dal novembre 1859 fino al 1869, anno in cui si fuse con il «Giornale dell'ingegnere civile e meccanico», per dare vita al «Politecnico. Giornale dell'ingegnere architetto civile e industriale», in un certo senso una logica continuità “tecnica” che sfuma sullo sfondo l’intento “civico”. Gli intenti del periodico vennero spiegati da Cattaneo così: «appianare ai nostri concittadini con una raccolta periodica la più pronta cognizione di quella parte di vero che dalle ardue regioni della Scienza può facilmente condursi a fecondare il campo della Pratica, e crescere sussidio e conforto alla prosperità comune e alla convivenza civile. […] Il bisogno di promovere fra noi ogni maniera d’industrie è ormai troppo manifesto […] Possa il Politecnico arrecare qualche eccitamento e qualche utile consiglio ad una generazione intraprendente, da cui lo Stato sembra potersi attendere nuovi incrementi di opulenza e di splendore» [16]. Per dare ai suoi lettori «la più pronta cognizione delle ardue regioni della Scienza», Cattaneo voleva che gli articoli scritti per «Il Politecnico» potessero essere agevolmente capiti, fino a intervenire sul testo, spesso crudamente, per renderli meglio conformi a questa esigenza di chiarezza.
Il «Politecnico» di Vittorini fu una rivista non solo bellissima nella sua essenziale “povertà” — grafica prima di Abe Steiner e poi di Trevisani, che successivamente disegnò il quotidiano “il manifesto” —, quasi un “programma grafico” di Mondrian o di Rodchenko, ma piena di innovazioni straordinarie, dall’uso delle immagini fotografiche alle illustrazioni, dai fumetti ai dipinti, con poesie, racconti a puntate [a esempio: Per chi suonano le campane, ovvero For Whom the Bell Tolls di Heminway, titolo “al plurale” sicuramente voluto da Vittorini], spaziando dal Giappone alla Grecia, dalla Spagna alla Cina, con inchieste [i primi tre numeri si aprono con una “Inchiesta sulla Fiat”, anticipando i «Quaderni Rossi», con interviste di operai e impiegati] e reportage, dalla Puglia alla Sicilia, e con un linguaggio didascalico dove si spiegava, a esempio, il rapporto tra salari e prezzi o alcune innovazioni tecniche dell’industria: insomma, un programmatico intarsio di linguaggi separati, una operazione narrativa “politecnica”, appunto, sui linguaggi espressivi dell’arte.
Per illustrare gli intenti del «Politecnico» — la “corrente Politecnico”, come poi la definì Mario Alicata, l’occhiuto e sprezzante organizzatore degli intellettuali compagni di strada del Partito comunista, quando scoppiò la polemica tra Vittorini e Togliatti — riporto qui alcuni stralci dell’editoriale del numero 12 dell’8 dicembre 1945 [17], Scuola umanistica o scuola tecnica?, di Giulio Preti, [si discusse molto sulla rivista di una necessaria riforma della scuola, con interventi importanti, fra gli altri di Concetto Marchesi] che si apre così: «Il difetto fondamentale dell’orientamento didattico della scuola media odierna è costituito da ciò: che non vi si impara nulla di quello che oggi serve all’uomo moderno e vi si insegnano molte cose inutili…». E prosegue: «Nell’“età della tecnica” l’uomo deve avere una capacità tecnica, ma non perciò cessa di essere uomo. La sintesi è data appunto da una mentalità razionalistica, scientifica, francamente e intelligentemente empirica, che implica e comprende in sé le attitudini tecniche ma le supera in un atteggiamento che diremmo più genericamente pratico».
Pratico, empirico. Sono i contenuti di quella battaglia di poetica che Vittorini poi sviluppò in un’altra rivista di fuoriclasse, «Il Menabò», in particolare nel numero 4 dedicato a Industria e Letteratura. «Il mondo industriale, che pur ha sostituito per mano dell’uomo quello “naturale”, è ancora un mondo che non possediamo e ci possiede esattamente come il “naturale”… Lo scrittore è di fabbriche e di aziende che racconta ma non ha interesse agli oggetti nuovi e gesti nuovi che costituiscono la nuova realtà attraverso gli sviluppi ultimi delle fabbriche e aziende… Lo scrittore parla un linguaggio di simboli per tutto ciò che riguarda le cose nuove e un linguaggio invece di cose (pur se ormai vecchio e invalido, e cioè pseudo concreto) per tutto ciò che riguarda le vecchie cose del mondo preindustriale che tutti continuiamo a vedere con gli occhi dei padri e dei nonni come se l’industria non le avesse, investendole dei suoi ritmi, modificate… E i narrativi, lungi dal trarre un qualunque vantaggio di novità di sguardo (e di giudizio) dalla nuova materia che trattano, sembrano invece trovarsene talmente impacciati che si comportano dinnanzi ad essa come se fosse un semplice settore nuovo d’una più vasta realtà già risaputa e non un nuovo grado, un nuovo livello dell’insieme della realtà umana: riducendosi con ciò a darne degli squarci pateticamente (e pittorescamente) descrittivi che risultano di sostanza naturalistica e quindi d’un significato meno attuale di altri testi letterari che magari ignorano del tutto la fabbrica, del lavoro specializzato, delle strutture aziendali, ecc. ecc. ma ne sono profondamente influenzati per riflesso dei loro effetti sulla condizione dell’uomo in generale» [18].
Il rifiuto della rottura umanesimo/antiumanesimo, l’ostinazione, cioè, a non lasciar considerare la tecnica come parte dell’antiumanesimo, che era stata la prevalente “ideologia del tempo” prima e dopo la riforma Gentile e intorno Benedetto Croce, e lo sguardo fisso sulle profonde trasformazione dell’umano dovute all’industrializzazione con il bisogno di trovare le “parole nuove”, una rappresentazione espressiva della letteratura che sapesse misurarsi con le “cose nuove”, fino quasi a proporre una separazione fra “industria” e “capitalismo”, il fastidio per il naturalismo descrittivo — quello francese dei Zola, delle “miserabili masse” — come per il “romanzo consolatorio” — da Manzoni a Mann, da Pasternak a Tomasi di Lampedusa —, sono i cardini della poetica di Vittorini come organizzatore culturale, come intellettuale militante.
Era l’Italia della ricostruzione, di un fallimento autarchico–produttivo e dello slancio industriale, che si interrogava su quale potesse essere non solo un “modello di sviluppo” ma un “modello di paese” verso il quale andare.
Tanto per esercizio retorico e per gioco di associazioni, potremmo provare a chiederci cosa avrebbero pensato della decisione del rettore e della corporativa opposizione di professori e ricercatori del Politecnico sia Cattaneo che Vittorini.
C’è un passaggio, fra le tante cose dette da Vittorini, che m’inquieta. È tratto da un testo per una progettata rivista internazionale, pubblicato nel «Menabò» numero 7. Eccolo: «Al principio del secolo, e subito dopo la guerra del ‘15–18, o anche sotto il fascismo, si sono avuti parecchi momenti in cui i contadini erano irrequieti, specie i più poveri, ed emigravano all’estero o venivano a lavorare in città. Ma si trattava in genere di correnti che cercavano solo un miglioramento economico, e al fascismo fu facile fermarle: con leggi di polizia, con richiami sotto le armi, e con piccole industrie che incoraggiò a sorgere in numerosi luoghi sperduti specie delle Prealpi, venete, lombarde o piemontesi. Oggi tutte quelle fabbrichette di villaggio difettano di mano d’opera nella stessa misura in cui ne difettano i campi, salvo qualcuna che, divenuta grande azienda, ha finito col trasformare da arcaico in tendenzialmente moderno l’ambiente sociale nel quale era stata inserita allo scopo di tenerlo fermo».
Vittorini stava parlando di Galbani e della sua industria in cui si produceva il formaggio Bel Paese?
La «Civiltà delle macchine» di Sinisgalli
«Civiltà delle macchine» [19] è una rivista bimestrale, di cultura, su carta lucida, in formato grande, che nasce negli anni Cinquanta come house organ del gruppo industriale pubblico Finmeccanica. Ha come direttore Leonardo Sinisgalli, che aveva già diretto la rivista «Pirelli» e che chiamerà a collaborarvi diverse firme del «Politecnico» di Vittorini [ma ce ne saranno molti altri, per dire qualche nome: Gadda, Buzzati, Moravia, Argan, Giansiro Ferrata, Tofanelli]. «Io volevo sfondare — dirà Sinisgalli in un’intervista del ‘65 — le porte dei laboratori, delle specole, delle celle. M’ero convinto che c'è una simbiosi tra intelletto e istinto, ragione e passione, reale e immaginario» [20]. Il primo numero del gennaio 1953 si apre con una lettera del poeta Giuseppe Ungaretti per spiegare la scelta del titolo ma in un certo senso anche il suo progetto: «Caro Sinisgalli […] la rivista che inizia con questo numero le sue pubblicazioni si propone di richiamare l’attenzione dei lettori anche sulle facoltà strabilianti d’innovamento estetico della macchina. Vorrei anche che essa richiamasse l’attenzione su un altro ordine di problemi: i problemi legati all’aspirazione umana di giustizia e di libertà. Come farà l’uomo per non essere disumanizzato dalla macchina, per dominarla, per renderla moralmente arma di progresso? […] Le calcolatrici elettroniche riescono a risolvere come niente equazioni che richiederebbero, se quei conteggi avesse da farli direttamente il matematico, anni e anni di lavoro, e forse gli anni non basterebbero; ma il prodigio non è qui: il prodigio metrico non è tanto nei prodotti di calcolo di quella macchina quanto nella macchina stessa: nei suoi congegni, nelle funzioni che, dai rapporti che tra di essi istantaneamente s’istituiscono, derivano, possono senza fine derivare. In quel prodigio di metrica noi possiamo ammirare il conseguimento di una forma articolata che, per raggiungere la sua perfetta precisione di forma, dovette richiedere ai suoi ideatori e ai suoi costruttori un’emozione non dissimile da quella, anzi identica a quella, cui il piacere estetico dà vita». Sull’«indiscutibile parallelismo» riscontrabile nella più recente operosità artistica con certe configurazioni tecnico–industriali insisteva pochi mesi dopo Dorfles, trattandone come d’una spontanea, creativa colleganza. Nel ‘55 un’esposizione sulle arti plastiche e la civiltà delle macchine verrà ideata a Roma, Galleria d’arte moderna, da Sinisgalli e da Enrico Prampolini: quadri e sculture si disporranno accanto a utensili d’acciaio, organi di trasmissione e colate di fonderia, così da svelare la propria «viscerale parentela». Le copertine della rivista sono bellissime. A volte rappresentano quadri di artisti contemporanei, a volte sono fotografie di oggetti naturali, che subiscono un processo di straniamento e si mostrano nella loro valenza artistica. La copertina del numero due del 1957 ha per titolo Trucioli della Terni ed è costruita con la fotografia di semplici e normalissimi trucioli residui della lavorazione dell’acciaio.
In un articolo del febbraio 1976 su «Il Mattino» di Napoli, Sinisgalli descrive La decadenza di Milano: «L’industria [...] è scaduta progressivamente perché è venuto a mancare, via via, lo stimolo, l’alimentazione, il controllo da parte della cultura. C’è una certa differenza tra la gestione della Olivetti, tenuta da Adriano Olivetti, e le successive gestioni di Peccei e Visentini. L’ing. Adriano (lo chiamavamo così, quaranta anni fa) era un capo appassionato e vivamente partecipe, fino all’esaltazione; mentre gli altri, dal poco che ho potuto dedurre da alcuni stralci di dichiarazioni, sono distaccati, gelidi, tutto sommato indifferenti. L’Olivetti si è andata normalizzando, appiattendo, ha perduto di anno in anno il lustro della sua immagine: “È diventata come la Fiat” mi confidavano i vecchi amici che incontravo di tanto in tanto. Mi dissero che a un certo momento si pensò perfino di affidare il budget pubblicitario a un’agenzia americana! Anche all’Alitalia, con cui ho avuto a che fare per qualche anno, si pensò di affidare la difesa dell’immagine a un’agenzia americana. Temo che abbia fatto lo stesso la Bassetti. E non so bene cosa è successo alla Pirelli dopo la morte di Arrigo Castellani, che, contro le tentazioni interne di molti filistei, riuscì a difendere la priorità dell’invenzione sull’amministrazione. La crescita a macchia d’olio delle agenzie pubblicitarie, preferite [...] agli uffici autonomi di una volta, la metto tra i motivi di decadenza di Milano. Alla città è venuto a mancare il sostegno dell’immaginazione. Del resto mi sono reso conto da tempo che la funzione dell’intellettuale, nell’industria non è più quella dei pionieri. L’intellettuale oggi considera come secondo mestiere il lavoro che fa nell’azienda: questa deve dargli gli alimenti non la gloria. La gloria è affidata ai quadernetti manoscritti che si porta in ufficio e che, quando si vede disturbato o si accorge di andare in trance posseduto dal demone, si trascina furtivo al cesso. [...] Gli intellettuali stipendiati dall’industria si incontrano meno al loro posto, ma più spesso nei comitati di redazione di giornali e riviste, nei corridoi delle case editrici, nei grandi alberghi, nelle librerie alla moda, ai vernissage, nei teatri, nelle giurie, nei convegni, nelle crociere politico-culturali» [21].
Industria e cultura italiana d’oggi
La pasta italiana è diventata nel mondo il piatto della crisi con le esportazioni che crescono del 27% in quantità e fanno registrare nel 2013 addirittura il record storico all’estero dove non sono mai stati consumati così tanti spaghetti, penne, tagliatelle, tortellini e rigatoni made in Italy. È quanto emerge da un’analisi della Coldiretti sui settori che resistono alla crisi e trainano la ripresa dell’economia nazionale, sulla base dei dati Istat relativi al mese di gennaio 2013. Il presidente della Coldiretti ha affermato che «l’Italia costruirà il proprio futuro tornando a fare l’Italia, ovvero valorizzando al meglio quello che ha già di unico e di esclusivo» [22].
Il nostro futuro produttivo è la pasta? Quello che sappiamo fare meglio è la pasta? Quello che abbiamo di unico e esclusivo è la pasta? A giudicare dai dati Istat diffusi nel febbraio 2013 sembra proprio così: «Crolla l’import di auto e computer ma l’export di vino e cibo made in Italy tocca il massimo storico di 31 miliardi di euro, circa il doppio delle vetture spedite sui mercati esteri. E anche il saldo commerciale complessivo non è niente male superando gli 11 miliardi di euro, il livello più alto dal 1999. In termini generali, secondo i dati Istat diffusi ieri, l’avanzo dei prodotti non energetici (alimentari, chimici e farmaceutici, petrolio raffinato) è stato di 74 miliardi rispetto a un disavanzo energetico di 63. A sorpresa, nonostante il rafforzamento dell’euro sullo yen e sul dollaro, i mercati esteri più dinamici sono stati gli Usa (+16,8%) e il Giappone (+19,1%). Male India e Cina con un ribasso medio del 10%. Non così però per i prodotti della dieta mediterranea che sulla piazza cinese hanno registrato un boom senza precedenti: 28% in più per l’olio, 84% per la pasta, 21% per il vino, 300% per il formaggio grana e il 500% per il prosciutto» [23].
La cultura si adegua all’andamento produttivo e delle esportazioni: «Con i propri studi e il proprio lavoro ha contribuito alla crescita morale, culturale e civile della nazione. Per questo Brunello Cucinelli, imprenditore italiano del cashmere, verrà premiato oggi a Roma, nella Biblioteca della Crociera del Collegio Romano, come “benemerito della Scuola della Cultura e dell’Arte”, riconoscimento conferito dal ministero per i Beni culturali. L’imprenditore filosofo — così definito per la sua passione per la filosofia, che non resta solo teorica, ma contagia anche il suo modo di fare impresa — nel 2010 aveva già ricevuto una laurea honoris causa in Filosofia ed Etica delle relazioni umane, oltre al Cavalierato del Lavoro. Ora il nuovo premio» [24].
Certo, il cashmere non è l’olio d’oliva o il parmigiano, però non è neppure quella “meccanica strumentale”, indicata in una recente intervista dal direttore del Dipartimento per l’integrazione, qualità e sviluppo delle reti di produzione e ricerca dell’Istat, Manuele Baldacci, come uno dei settori di punta su cui investire per una possibile crescita [25]. In ogni caso, è difficile immaginare l’Italia verso cui vogliamo andare come il paese in cui si produca cashmere. La cultura si adegua al cashmere: «Dal cashmere al Salone del Libro. Oggi in Sala Azzurra alle 12, l’imprenditore Brunello Cucinelli, cui è legato uno dei marchi più noti del made in Italy d’alta gamma, tiene una lectio magistralis sul tema dei Laboratori della creatività» [26]. Ecco un florilegio di citazioni dalla lectio magistralis di Cucinelli: «Dobbiamo imparare a coccolarci di più… Da noi si lavora come Benedettini, mente, anima e preghiera. Mente e anima si devono incontrare… Credo nella dignità dell’uomo. Si è creativi quando l’ambiente di lavoro è un po’ speciale… Potrei scommettere un milione di dollari: per la nostra Italia e la nostra Europa il meglio deve ancora venire… I libri mi hanno indicato la vita e la vita mi ha fatto capire i libri. Dei libri non potrei farne a meno» [27].
Se non è culturalizzazione pop dell’impresa, questa…
Il «prodigio metrico» del lavoro precario
In un recente pamphlet, che è riassunto e messa a nudo della propria poetica, Walter Siti scrive: «Dal mio punto di vista, è necessario segnalare quanto ci sia di contrario al realismo nelle scritture che più sembrano rilanciarlo. Se il realismo significa sospendere e battere in breccia gli stereotipi, allora saranno nemiche del realismo tutte le cadute in una qualunque forma di stereotipia. Spesso da alcuni testi–capostipite, in cui l’esperienza della realtà è intensa e originale, nascono filiere e sottogeneri che tendono pian piano alla maniera; pensiamo per esempio ai “romanzi sul precariato”, che a partire da Pausa caffè di Giorgio Falco (o da Il mondo deve sapere di Michela Murgia) sono diventati un vero e proprio filone della recente editoria: pieno di cliché giovanilistici, sapido di un’ironia e autoironia che ammicca all’antico sottogenere del romanzo aziendale, tra Frassineti e Villaggio» [28].
L’Italia non è più un paese dove sia possibile dare ascolto al «prodigio metrico» delle macchine, di cui parlava Ungaretti scrivendo a Sinisgalli per la rivista di Finmeccanica. Non è per infierire, ma la miserabilità scandalistica che ha investito e travolto proprio la Finmeccanica è un’epitome del nostro “stadio industriale”. Forse, come abbiamo vissuto una modernizzazione selvatica, disordinata e arrembante — passando in un breve volger d’anni da paese agricolo a paese industriale, con la difficoltà e la resistenza di raccontare questo «nuovo livello dell’insieme della realtà umana», come scriveva Vittorini —, ci è toccato in sorte un post–industrialismo, un postfordismo selvatico, disordinato e arrembante.
Eppure, nella metrica del lavoro precario — che è la forma propria della “macchina linguistica” della forma del capitale d’oggi, «un mondo che non possediamo e ci possiede» — a me sembra possibile rintracciare quel linguaggio di parole e cose capace di spaccare la realtà, di leggerne e “tradurne” il conflitto.
Conclusioni
«Ogni momento di crisi economica porta con sé nuove opportunità a chi è in grado di coglierle, e sono i creativi culturali, in senso lato, ad essere i primi interpreti di un mondo che cambia. Le master class della scuola Holden vogliono mettervi a diretto contatto con le storie di successo di chi in questa fase di cambiamento ha saputo osare».
È il programma della Scuola Holden di Torino, quella fondata da Alessandro Baricco, per le Master Class 2012 [29].
«Docenti di alto profilo — Abbiamo scelto come docenti, professionisti che ricoprono un ruolo di assoluto market leader nel loro settore. Il primo workshop sarà tenuto da Jeanne Bordeau, esperta di comunicazione aziendale e docente alla Sorbona a Parigi. Per riassumere: Branding e comunicazione d’impresa, quali frontiere? Contenuti didattici:
- Analisi della coerenza linguistica nelle imprese (dal management alla pubblicità).
- Analisi linguistica (come riconoscere le tipologie di parole).
- Creazione del linguaggio di un brand (come usare le parole giuste per un prodotto)».
Di Jeanne Bordeau, docente della Master Class, «assoluto market leader», si dice che «parlerà della creazione del linguaggio di un brand, ovvero di come usare le parole giuste per un prodotto e dell’importanza della coerenza linguistica nelle imprese».
L’importanza della coerenza linguistica nelle imprese. Non è proprio ciò che “inventò” Egidio Galbani col suo Formaggio del Bel Paese? C’era proprio bisogno di rispolverare gli «uso Francesi»?
Nicotera, 1 giugno 2013
[1] Dal sito ufficiale della Galbani: http://www.galbani.it/prodotti/bel_paese/storia/storia.html
[2] Carlo Ginzburg, Il formaggio e i vermi, Einaudi, 1976
[3] Mario Isnenghi, Storia d’Italia – I fatti e le percezioni dal Risorgimento alla società dello spettacolo, Laterza, 2011
[4] Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno, Canto XXXIII
[5] Petrarca, Canzoniere, Sonetto CXLVI
[6] Elio Grazioli, Arte e pubblicità, Bruno Mondadori, 2001
7 Claudia Salaris, Il futurismo e la pubblicità, Lupetti & Co., 1986
[8] Qui: http://it.wikisource.org/wiki/Sulla_maniera_e_la_utilità_delle_Traduzioni
[9] A. Gramsci, Letteratura e vita nazionale, Einaudi, 1953
[10] Silvana Patriarca, Italianità. La costruzione del carattere nazionale, Laterza, 2010
[11] Tullio De Mauro, Storia linguistica dell’Italia unita, Laterza, 1963
[12] Workshop della prof.ssa Adele D’Arcangelo, docente di traduzione Inglese/Italiano presso l’Università di Bologna, si può vedere qui: http://www.vittorininet.it/supporto/elio/totale_approfondimenti.htm
[13] «La Lettura», inserto del «Corriere della Sera», domenica 26 maggio 2013
[14] Stefano Jossa, L’Italia letteraria, il Mulino, 2006
[15] Si può leggere qui: http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/rd1592_33.pdf
[16] «Il Politecnico, Repertorio mensile di studj applicati alla prosperità e coltura sociale», Volume 1, Anno Primo = Semestre Primo, 1839. Si può leggere qui: http://it.wikisource.org/wiki/Il_Politecnico
[17] «Il Politecnico», ristampa anastatica, Einaudi, 1975
[18] Ho perduto il numero 4, ma mi è rimasto il numero 10, curato da Italo Calvino, che contiene un florilegio di citazioni da Vittorini — articoli, interviste — tra cui diverse relative al numero 4. «Il Menabò», 10, Einaudi, 1967
[19] V. Scheiwiller (a cura di), Civiltà delle macchine. Antologia di una rivista 1953-1957, Scheiwiller, 1989
[20] http://www.fondazionesinisgalli.eu/
[21] http://mpigreco.altervista.org/a/recensioni/civiltadellemacchine.html
[22] http://www.agi.it/economia/notizie/201305111018-eco-rt10024-crisi_boom_per_la_pasta_italiana_all_estero_27
[23] «Corriere della Sera», 16 febbraio 2013
[24] «Corriere della Sera», 19 aprile 2013
[25] «GliAltri» online: http://www.glialtrionline.it/2013/05/29/istat-nessun-allentamento-dellausterity-niente-crescita-per-i-prossimi-80-anni/
[26] «Corriere della Sera», 18 maggio 2013
[27] http://censurer16.tawaba.com/chan-9025639/all_p3.html
[28] Walter Siti, Il realismo è l’impossibile, Nottetempo, 2013
[29] http://old.scuolaholden.it/Fondamenta/masterclass-fondamenta |
 |
| [torna
su] |
 |
|
|