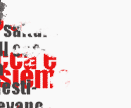|
|
|
24 Agosto 2013
C’è scelta in Egitto? |

 Forse, l’analisi politica più puntuale di quanto sta accadendo in Egitto si può ritrovare nelle parole di Khalid Abdalla, l’attore britannico di origine egiziana, star di film di grande successo internazionale come United 93 e Green Zone, che alla caduta di Mubarak ha fondato al Cairo un gruppo di attivisti dei media — Mosireen, un’espressione araba che significa “Siamo determinati” — per documentare lo svolgersi degli eventi fin dalle prime manifestazioni di piazza Tahrir. «These are dark days», sono giorni bui, ha detto. Forse, l’analisi politica più puntuale di quanto sta accadendo in Egitto si può ritrovare nelle parole di Khalid Abdalla, l’attore britannico di origine egiziana, star di film di grande successo internazionale come United 93 e Green Zone, che alla caduta di Mubarak ha fondato al Cairo un gruppo di attivisti dei media — Mosireen, un’espressione araba che significa “Siamo determinati” — per documentare lo svolgersi degli eventi fin dalle prime manifestazioni di piazza Tahrir. «These are dark days», sono giorni bui, ha detto.
Delusione, frustrazione, impotenza: quanto è profondo lo sconforto, quanto è grande l’area dello scontento di chi si era battuto per la caduta del regime di Mubarak, si è ritrovato con l’incompetenza e l’autoritarismo dei Fratelli musulmani, e ora non riesce a riconoscersi nel golpe del generale al Sisi e dell’esercito, ma neppure nei “venerdì della rabbia” delle moschee? Una matassa di sentimenti contrastanti.
La polarizzazione dell’Egitto è estrema, e sembra coinvolgere il paese tutto: alle manifestazioni contro Morsi del 30 giugno per chiedere le sue dimissioni avrebbero partecipato trenta milioni di egiziani; a quelle di sostegno a Morsi, perché ritorni dove è stato spodestato dai generali, si parla di milioni di presenze. D’altronde il partito di Libertà e Giustizia, il braccio politico della Fratellanza, aveva preso il 52 per cento dei voti, e anche se può ragionevolmente considerarsi fluido il voto, qualcosa di significativo si è sedimentato. E poi ci sono le moschee, da dove si parte per scendere in piazza. Cosa rimane fuori dalle barbe islamiste e dalle divise militari, un pugno di sabbia?
Da una parte l’esercito che aggrega attorno a sé una variegata alleanza di salafiti, cristiani copti, giovani attivisti di Tamarod (Rivolta) che hanno animato le proteste contro Morsi, partiti dell’opposizione, ex sostenitori del regime di Mubarak, e che sembra ormai deciso a ricacciare nella clandestinità i Fratelli musulmani, come fece Nasser; dall’altra, i Fratelli musulmani e una loro alleanza la cui posizione si può riassumere nelle parole dei giovani che hanno occupato e tenuto piazza Rabaa, uno dei centri della protesta contro l’esercito, lasciandoci centinaia di morti: «Ammazzateci, picchiateci, puniteci, ma noi non ci fermeremo finché Morsi non torna».
Non c’è spazio per alcuna mediazione. Per dire, El Baradei, che cerca sempre spiragli di trattativa e si è dimesso da vice presidente del nuovo governo insediato dopo Morsi perché assolutamente in disaccordo con la repressione dell’esercito, ha fatto giusto in tempo a volare a Vienna e già c’è un mandato di cattura nei suoi confronti per tradimento. Tradimento di chi? Di Morsi, dei generali? L’accusa potrebbero fargliela l’uno e gli altri.
D’altronde, la polarizzazione si è riproposta a livello dell’area: a fianco del generale al SIsi c'è l'Arabia Saudita — il re in persona ha pronunciato una dichiarazione pubblica a sostegno dell'esercito egiziano «in lotta contro il terrorismo». E ci sono anche gli Emirati Arabi Uniti, il Kuwait, la Giordania. Sul fronte opposto, accanto ai Fratelli Musulmani, si trova il primo ministro turco Erdogan, insieme al Qatar che ha offerto al movimento la sua principale piattaforma mediatica mettendo il canale Al Jazeera al servizio della sua conquista del potere. E della protesta. Marocco, Turchia, Giordania, Libia, Sudan, Pakistan, Yemen, ma anche Gaza e Ramallah, e perfino Gerusalemme, di fronte alla moschea di Al Aqsa: le proteste contro il golpe che ha deposto Morsi hanno portato in piazza musulmani di tutto il mondo; le manifestazioni sono arrivate anche in Indonesia e Malesia. E in Europa.
L’esplosione dell’Egitto, il più grande paese sunnita del Medio Oriente che conta più di novanta milioni di abitanti, ha rimescolato le carte anche dentro lo scenario di uno “scontro di civiltà” tra sunniti e sciiti che poteva sembrare una chiave di lettura dei sommovimenti nell’area. Da una parte una “mezzaluna sciita” diretta da Teheran e che si appoggiava all’Iraq di Maliki, la Siria di Assad, Hezbollah e le popolazioni sciite della costa araba del Golfo; dall'altra, un fronte sunnita i cui leader principali erano l'Arabia Saudita, il Qatar, la Turchia e l'Egitto. Non è più così: il blocco sunnita si trova profondamente scisso. Lo scontro tra sunniti e sciiti spiega alcune dinamiche, ma non tutte.
È davvero difficile trovare un bandolo di matassa: Morsi aveva rotto con Damasco sperando di accattivarsi i salafiti egiziani, che invece gli si sono schierati contro; Erdogan condanna i generali, ma tutti in Turchia sembrano farlo, dall’estrema destra ai curdi. E nella guerra civile in Siria la maggioranza sunnita della popolazione lotta contro la dittatura di Al Assad, una coalizione di minoranze di alawiti, cristiani, drusi, curdi, oltre ad alcuni sunniti. Il conflitto che vede schierati gli islamisti da un lato e quelli che gli si oppongono dall'altro — in Egitto come in Libia, in Tunisia e in Turchia — spiega altre dinamiche, ma non tutte.
Dopo “l’era Bush” — l’esportazione della democrazia con la guerra — la politica degli Stati uniti nell’area è quella di un progressivo disimpegno, non solo dalle zone di guerra, che era la promessa elettorale di Obama. Una minore dipendenza dal petrolio arabo e lo sguardo fisso verso la Cina, oltre a una maggiore attenzione alle questioni sociali interne, a cominciare dalla ripresa economica e dalla lotta alla disoccupazione, sono i cardini della politica democratica americana di adesso. Si rimprovera a Obama di non esercitare pressione sui generali egiziani minacciandoli di ritirare quel miliardo e mezzo di dollari che anno dopo anno serve all’esercito per mantenersi come asse principale dell’economia del paese. Ma non si tiene conto che Riad e gli emirati hanno inondato di petrodollari i generali, e già prima del golpe, quasi dieci volte l’aiuto americano, di cui un terzo depositato nelle banche del Cairo. Il golpe, cioè, prescinde dall’opinione americana, e non parliamo di quella europea, o perlomeno presuppone di poterne fare a meno — e quando mai gli americani si straccerebbero le vesti per degli islamisti in nome della democrazia?
Nel Medio Oriente si è aperta la corsa a costruire la potenza dell’area, probabilmente puntando anche a esercitare influenza su tutto il Nord Africa. Il populismo islamista — quella capacità di intercettare, e spesso soccorrere, le esigenze minime dei più bisognosi — che sembra interessato alla forma della democrazia solo per potervi vincere le elezioni e poi esercitare un potere autoritario è uno dei soggetti politici più forti, in grado di esprimere influenza e consenso oltre ogni confine, ma non può, da solo, “fare potenza”. Sarà la base delle nuove definizioni di stati nazionali e delle forme della partecipazione e decisione popolare? O invece saranno le élites militari, da sempre detentori della forza, un’opzione tenuta in congelatore ma che ci vuole poco a tirare fuori e “servire”, a fare potenza, come già accadde nel nazionalismo panarabo? Resisteranno le monarchie petroliere?
Sembrano tutti tentativi di “mettere ordine” in fretta dopo i sollevamenti della primavera araba, vero bing bang del mondo musulmano, di chiudere le rivoluzioni. Ci vorrà tempo per capire quali scenari si consolideranno. E noi europei faremmo bene a smettere quell’aria di sopracciò. Le nostre democrazie sono nate da decapitazioni, bagni di sangue e guerre religiose. Erano giorni bui, quelli?
Siamo determinati a guardare avanti.
Nicotera, 24 agosto 2013 |
 |
| [torna
su] |
 |
|
|