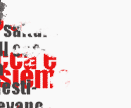|
|
|
16 Novembre 2013
Mon coeur mis à nu |

 Pochi giorni dopo la sua morte ho sognato che ci trovavamo in una grotta, cui eravamo arrivati attraversando un cunicolo sotterraneo, rischiarata tenuamente da fiaccole e davanti un ingresso chiuso da un masso. Ero seduto, accovacciato davanti quel masso e tenevo tra le mani una tavoletta, come di cera ma sembrava più fosse un tablet, sulla quale avrei dovuto scrivere con un dito una password che avrebbe spostato il masso enorme e spalancato l’accesso. Non ricordavo più la password. Ne provavo alcune, senza esito. Paola era impaziente e, come sempre quando mi coglieva in fallo o impreparato, iniziò a stuzzicarmi – la divertiva molto – ma sembrava anche irritarsi progressivamente e preoccuparsi. Non potevamo restare di qua, o comunque si doveva andare di là. Qualcosa urgeva. Mi svegliai di colpo. Ero felice per averla sognata – la prima volta. Sorridevo anche per quel gioco di sprone e critica che faceva parte della nostra grammatica di vita comune – non era cambiato nulla, perciò, non ancora almeno – e era rimasto uno spazio e un tempo, i miei sogni, in cui avrei potuto riprodurla all’infinito. Ero anche inquieto però. Gli Inferi si erano informatizzati, Caronte si era trasformato in un nerd? Serviva una password anche per passare di là, adesso, un codice captcha? Il nostro destino, il fato era già programmato in qualche algoritmo? Sentivo pure la colpa per quell’amnesia improvvisa che le impediva il passaggio. Io sarei andato con lei, se l’aspettava? Come avrei potuto lasciarla andare da sola, consentire a che affrontasse da sola questo viaggio, l’ultimo viaggio – io, I promised I’ll never leave you, no matter where you are? Forse avevo coscientemente traccheggiato per impedirle di andare via, per trattenerla con me, pensai anche questa possibilità. Per ingannarla, insomma. L’Ade greco, gli Inferi romani, il lago d’Averno di Virgilio non è un luogo, uno spazio esterno a noi – coordinate: 40° 50′ 20.4″ N – ma il nostro cuore. Si scende nel nostro cuore. È nel nostro cuore che si affrontano Cerbero, Caronte, lo Stige e il Lete. E non ci sono barche e oboli sufficienti. Solo le parole possono aiutarci, salvarci. Le parole per passare, le password. Le parole per evocare. Per restare. Pochi giorni dopo la sua morte ho sognato che ci trovavamo in una grotta, cui eravamo arrivati attraversando un cunicolo sotterraneo, rischiarata tenuamente da fiaccole e davanti un ingresso chiuso da un masso. Ero seduto, accovacciato davanti quel masso e tenevo tra le mani una tavoletta, come di cera ma sembrava più fosse un tablet, sulla quale avrei dovuto scrivere con un dito una password che avrebbe spostato il masso enorme e spalancato l’accesso. Non ricordavo più la password. Ne provavo alcune, senza esito. Paola era impaziente e, come sempre quando mi coglieva in fallo o impreparato, iniziò a stuzzicarmi – la divertiva molto – ma sembrava anche irritarsi progressivamente e preoccuparsi. Non potevamo restare di qua, o comunque si doveva andare di là. Qualcosa urgeva. Mi svegliai di colpo. Ero felice per averla sognata – la prima volta. Sorridevo anche per quel gioco di sprone e critica che faceva parte della nostra grammatica di vita comune – non era cambiato nulla, perciò, non ancora almeno – e era rimasto uno spazio e un tempo, i miei sogni, in cui avrei potuto riprodurla all’infinito. Ero anche inquieto però. Gli Inferi si erano informatizzati, Caronte si era trasformato in un nerd? Serviva una password anche per passare di là, adesso, un codice captcha? Il nostro destino, il fato era già programmato in qualche algoritmo? Sentivo pure la colpa per quell’amnesia improvvisa che le impediva il passaggio. Io sarei andato con lei, se l’aspettava? Come avrei potuto lasciarla andare da sola, consentire a che affrontasse da sola questo viaggio, l’ultimo viaggio – io, I promised I’ll never leave you, no matter where you are? Forse avevo coscientemente traccheggiato per impedirle di andare via, per trattenerla con me, pensai anche questa possibilità. Per ingannarla, insomma. L’Ade greco, gli Inferi romani, il lago d’Averno di Virgilio non è un luogo, uno spazio esterno a noi – coordinate: 40° 50′ 20.4″ N – ma il nostro cuore. Si scende nel nostro cuore. È nel nostro cuore che si affrontano Cerbero, Caronte, lo Stige e il Lete. E non ci sono barche e oboli sufficienti. Solo le parole possono aiutarci, salvarci. Le parole per passare, le password. Le parole per evocare. Per restare.
Caitanello Cambrìa – pescatore dell’Horcynus Orca di D’Arrigo – sa tutto questo per natura. E la sua natura è il mito. Il mito, per così dire, a pelle, sovrappensiero. Il mito delle cose che ci stanno intorno, di ciò che coglie lo sguardo. È la mia stessa natura, e non ne ho alcun merito. Mi basta scendere alla marina e vedo le sue stesse cose, a specchio, di qua del golfo dell’Aria, vedo le Eolie e lo Stromboli che fuma, l’altra faccia, e vedo Sparta e Acqualatroni dove lui vedeva Nicotera e Bagnara e Palmi, vedo lo scill’e cariddi e le sue correnti, vedo le fere e le feluche – è solo il senso di marcia che è diverso, dove per me dritta, per lui sinistra, e viceversa – e le pescespadesse fianchipieni e i maschi puddicinedda, e i saraghi e le ricciole e la ciciredda. Solo l’Orca non vedo, ma la sento, la sento sommergersi e aggallare e soffiare, la terribile Horcynus Orca che sta sempre morendo e forse no e nel morire e forse no conferma la sua immortalità. La sua immortalità di morte, la sua mortale immortalità. Non la vedo ma la sento perché è nel mio cuore, che il dolore ha ingigantito quanto tutto lo Stretto che sta qui davanti me, e lì troneggia e porta carestia di mare perché tutto assomma e strazia nel lutto.
Facevamo l’amore ridendo. Da ragazzi no, eravamo furiosi, un po’ come tutti. Forse è stato questo il segno più tangibile della nostra maturità. Per me, anche della nostra unicità. Ridevamo di noi stessi, dell’inesorabile lentezza dei nostri corpi, del loro improbabile aggrovigliarsi e del loro declino, con l’ironia che prendeva le distanze da quelle obbligazioni cui ci sottoponeva la fisiologia dei nostri sensi, ma anche con la gioia di vedere rinnovato – quasi assistessimo a un miracolo – il desiderio dell’altro, attraverso qualcosa che esuberava ormai la carnalità stessa, addomesticata, allenata, eppure qui si inverava, si appagava, complice. Ci sentivamo buffi, ogni volta, eppure toccati da una grazia, ogni volta. A volte, senza dircelo, lo facevamo proprio per quello, per rinnovare una sacralità, per assistere noi stessi al miracolo, per compiere con le nostre mani, i nostri corpi, il miracolo. Ridere era liberarsi da quella tensione dell’attesa, dalla paura che il sangue dei nostri corpi non si sarebbe squagliato. Invece potevamo mostrarli come ostensori. Il calvario dell’ultimo anno e mezzo – il primo intervento, la stomia poi richiusa, la prima chemio, il secondo intervento, l’inizio della seconda chemio, gli ultimi giorni – è stato un percorso corporale, di cicatrici, di vene, di unguenti, di umori. Lo compimmo insieme – io la pulivo, la lavavo, la cambiavo, sistemavo le flebo, la fasciavo, la incerottavo, facevo le iniezioni, misuravo le medicine, sciacquavo gli indumenti, quelle mutandine bianche di cotone e alte in vita che odiava e quei reggiseno che disprezzava intanto che si facevano sempre più grandi man mano che si svuotava di carne, la vestivo e la svestivo – tra rabbia e amorevolezza, ora dell’uno ora dell’altra. Ero furioso contro il suo corpo che non rispondeva alle mie attese e mi relegava intrappolato in quel ruolo di assistenza, che svolgevo con meticolosità e timore, eppure speravo ancora nella sua irriducibile resistenza, invece lei stessa sapientemente ne stava prendendo le distanze – soprassaltava se le facevo una carezza, come fosse disgustata di quel corpo e sprezzante verso un mio gesto che intendeva ormai solo caritatevole, o di cura. Quale miracolo avremmo potuto più compiere assieme? Con quale corpo, che ormai era sfuggito via, ci si rivoltava contro? Ho pensato che quell’impazzimento di cellule fosse una forma di vendetta, per invidia e gelosia, per quello che eravamo riusciti a strappargli contro ogni logica, contro l’usura del tempo.
Caitanello Cambrìa fa le voci, la sua e quella dell’Acitana, la moglie. Gli fa senso, al figlio ‘Ndrjia che involontariamente origlia, sentire «quella voce smorfiata alla femminina» proferita da un pelle-squadra dei più tosti, asciutto e duro come il legno delle loro barche, spiccio e onesto come il lancio della traffinera per colpire il pescespada. Il pudore non abita più i cuori dei dolenti – «l’intimità è un poco spubblicata», scrive D’Arrigo. La morte di Amalia e il dolore dell’assenza non possono impedire a Caitanello di proseguire la conversazione – «Ci si sposa per proseguire la conversazione», Julian Barnes cita la frase di Ford Madox Ford nel suo Livelli di vita. Conosce, Caitanello come chiunque abbia avuto una lunga storia d’amore, ogni battuta del loro copione, ogni regola grammaticale del loro rapporto linguistico – ogni storia d’amore si sedimenta attraverso un rapporto linguistico, costruisce e istituzionalizza una lingua. E come chiunque sia rimasto nell’assenza della propria compagna, Caitanello ricostruisce e perpetua quel loro linguaggio perché solo il linguaggio allontana temporaneamente – per il tempo della sua espressione, nel prolungare la conversazione – la morte. Di più, Caitanello, che abita il mito e quindi per istinto di natura il dramma, mette in scena la rappresentazione quotidiana delle loro vite, di Granvisire e Masignora, i nomi che si erano dati. Fa le voci e le parti. Dice Barnes, che interroga e ottiene risposte dalla compagna morta, che però c’è un limite al proprio «ventriloquismo»: «Posso ricordare, o immaginare, che cosa dirà riguardo a cose già successe in passato. Non so dare voce alla sua reazione su eventi nuovi». È un problema che non tocca Caitanello, che non vive la storia che non abita qui, sullo scill’e cariddi. Granvisire e Masignora. «Quasi mai cambiavano, quasi mai ci mettevano novità di parole, quasi mai d’altronde cambiavano le cose, quasi mai la vita ci metteva novità di fatto e di fatti». Ci sono i mesi con la «r» nei quali non si vede pesce e ci sono i mesi senza «r», da maggio a agosto, quando c’è la passa. Che altro? Oh, ma le cose che possono dirsi, le parole che possono pronunciarsi. L’amore. Non è questo l’amore, inventare parole senza che nulla accada, inventare parole perché un mondo accada? E non è proprio a petto della morte – quando più nulla potrà mai accadere – che l’amore si fa più grande, più capace di inventare parole, di far accadere il mondo? Sempre le stesse, sempre diverse, perché così è l’amore, sempre lo stesso, sempre diverso. Perché così è il dolore.
Ho donato una parte delle sue scarpe – l’accessorio che amava di più –, non riesco a darle via tutte, e ne ho conservate parecchie a cui sono particolarmente affezionato o che lei teneva con più considerazione. Non è facile donare le sue cose, Paola era davvero minuta e il suo numero di piede non è quasi più in produzione, solo nei campionari. Però, la signora bulgara che viene a pulire casa ha una sorella minuta anche lei, e poi una ragazza rumena che in paese fa la badante e ancora le figlie del giovane africano che raccoglie le arance a Rosarno. Le sue scarpe sono partite, verso l’est verso il sud, in posti lontani. In pellegrinaggio. Credo che le farà piacere, non tanto per l’esotismo dei luoghi e non solo per la lieve carità del gesto ma perché le sue scarpe cammineranno ancora. E con esse il suo passo.
Caitanello Cambrìa, la Morte – Nasodicane, Nasomangiato – di puttana la prende e di puttana la lascia. «Eh? Mi senti? Eh? Già ti mettesti alla misa, eh? E puoi fallire, lordona tutta ossa? Senti che mi vado ad abboccare con l’Acitana e issofatto scappi, lasci denaro a contare e mi ti presenti. Avanti, Nasomangiato, forza vieni, opponiti al nostro purpalere, opponiti se hai l’alma, marfisara, vieni e facci il solito contrasto…». Per evocare l’Acitana, Caitanello deve sfidare Nasomangiato, deve stanarla. «Perché l’Acitana gli arrivasse là, pareva che Caitanello doveva prima figurarsi di apparolarsi con Nasodicane, doveva passare per lei». La Morte non fa musione, non risponde, non si appalesa, da un orecchio le entra e dall’altro le esce. «Di bocca, una parola che era una, non gliel’avrebbe mai strappata». La Morte è morte delle parole, il buco nero dove la nostra rabbia, i nostri insulti, le nostre preghiere vanno a infilarsi per scomparire. Per collassare. Tutto il coraggio di Caitanello – lui che aveva sfidato branchi di fere e ferito il capo-capo dei celeberrimi ‘grampi grigi’, l’impestato Manuncularais – non serve a nulla contro Nasodicane, vigliacca e traditrice, marfisara rapitrice. La Morte si sottrae alle parole. Dovrei sentirmi rincuorato, io che non posso raccontare di combattimenti così mitici, per non essere riuscito a vincere la morte. Eppure questo mi angoscia, la mia inadeguatezza. Ero stato scelto da Paola per essere il suo cavaliere senza macchia e senza paura, colui che avrebbe sfidato e vinto qualsiasi cosa per trattenerla a me. E invece ho perso una battaglia che non ho neppure combattuto, sono stato una buona crocerossina, niente di più, ero nelle salmerie non in prima linea, roba di stomaco, non di fegato. Con generosità, Paola mi disse: «Questa volta non ce la faremo», come se io davvero stessi guerreggiando insieme a lei, e non piuttosto limitarmi a curare le sue ferite, le sue piaghe. È stato un privilegio raro assisterla, ma non sono stato buono a niente. Ha combattuto da sola, la più importante delle battaglie. E tutto questo non serve a niente. Caitanello «parlava troppo per fare fatti e Nasodicane, per parte sua, taceva troppo per non farli, per cui quanto più vinceva a parole, tanto più perdeva nei fatti». Può essere solo il mio cuntu per una guerriera fiera e impavida e valorosa, come una Dama Rovenza nell’Opera dei pupi. Perché si sappia. Perché si racconti.
Credo sia contenta che Alice Munro abbia vinto il Nobel. Tra le sue mani avevo poggiato proprio un libro della Munro, In fuga – stava sul suo comodino, la sua scrittrice più amata benché a entrambi La vista da Castle Rock ci avesse poco convinti – perché le tenesse compagnia e la distraesse durante il viaggio. È stata solo una facile scelta più che una fortunata intuizione, c’erano anche Oz e la Oates e la Lessing e la Lahiri. Quando la cremerò, le parole della Munro si sfarineranno con lei. E questo le sarebbe proprio piaciuto. Nel mio pubblico commiato – la breve orazione che ho tenuto al cimitero, cercando di non essere prolisso, per non annoiarla – ho invece letto Javier Cercas, Soldati di Salamina, le ultime pagine, quelle in cui racconta dell’incontro con Bolaño. È l’ultimo libro che abbiamo letto assieme, che ci siamo scambiati, quello di cui mi ha indicato un passaggio – non aveva più forza per tenere un libro tra le mani –, che voleva le cercassi e le ripetessi. Ho letto le pagine in cui Cercas cita i nomi di sconosciuti ragazzi di Terrassa che caddero per la repubblica di Spagna combattendo contro Franco, e li nomina una, due, tre volte, quelli che non avranno mai «nessuna strada miserabile di nessuna città miserabile di nessun paese di merda che porterà il loro nome, i fratelli García Segués – Joan e Lela – e Miquel Cardos e Gabi Baldrich e Pipo Canal e Odena detto “Ciccio” e Santi Brugada e Jordi Gadayol». Alla fine della cerimonia mi si è avvicinato un amico dicendomi: «Si saranno voltati, oggi, tutti quei ragazzi, sentendo i loro nomi».
«Caitanello posò il lume sul canterano e armeggiò dentro l’armuaro… tirava fuori, appese alle stampelle dove le aveva sistemate lei stessa con le scaglie di naftalina nelle tasche le vesti dell’Acitana… Era come se lui fosse convinto che la sua Acitana, questione di tempo, ma sarebbe tornata: questo doveva sembrargli, ogni volta che metteva nelle tasche delle sue vesti quelle scaglie argentate. Durante gli anni nemmeno una volta aveva lasciato che, consumandosi le scaglie, le vesti rimanessero senza naftalina: finché si ricordava di mettere la naftalina alle sue vesti, per fargliele ritrovare intatte, bell’e pronte perché le indossasse, le speranze di vederla tornare non erano tutte perse». Apro anch’io l’armuaro tutte le mattine e tutte le mattine prendo in mano le sue vesti per odorarla ancora. Le vesti di Paola sono ben più di quelle dell’Acitana – «Erano tre: una azzurra, una viola e una verdina con rose bianche, tutte e tre di stile collegiale con le maniche lunghe, il collo abbottonato, quella viola, però, aveva un nastrino rosa attorno al collo e quella azzurra era un poco scampanata dietro» – e certe volte le dicevo che a quel suo armuaro succedeva come si dice accada nella metropolitana di Tokio dove ci sono degli addetti che spingono dentro le persone a forza per poter chiudere le porte e far ripartire il treno. Donava le sue cose, ma solo alla fine di un percorso lungo di elaborazione e distacco – e qualcuno dei suoi maglioni o dei suoi abiti sono rimasti con noi una vita intera e sono ancora qui. Nell’ultimo anno e mezzo non aveva più comprato nulla. Giravamo per i negozi di Roma o Messina, ma non c’era nulla che le piacesse, nulla che sembrava caderle bene addosso. Così, riaggiustava sue vecchie cose, rifaceva gli orli, stringeva sui fianchi, tirava le spalline. Proprio in occasione dell’ultima chemio, a Messina, entrammo in un negozio di Zara. Insistetti per regalarle un maglione, lo provammo nei camerini, e le piaceva il colore – un acceso ciliegia – e la lavorazione a coste inglesi, e costava poco. S’era lasciata convincere, forse per farmi contento. Mentre andavamo alla cassa le venne la nausea e l’istinto di vomitare. Si mise la mano sulla bocca e cominciò a scappare verso l’uscita e io con lei. Per fortuna proprio di fronte il negozio c’era un cestino dei rifiuti e vomitò lì dentro. Si asciugò e poi guardò il mio braccio e disse, e quello? Era il suo maglione, che non avevo pagato ma che era miracolosamente sfuggito ai rilevatori antitaccheggio. Pensa quante volte ci siamo industriati per superarli e stavolta… Ce l’ho qui, il maglione, nell’armuaro, ha ancora il cartellino del prezzo attaccato eccetera. Non ha il suo odore, e mi limito a guardarlo. Mi fa dolore, ma non posso fare a meno di tenerlo. Ci ho messo dei fogli antitarme, piegandolo. Li cambierò, a ogni stagione.
Ho sistemato di nuovo la nostra vecchia radio Geloso a valvole, che comperammo da un rigattiere. C’è un racconto di Cheever che l’aveva colpita – non saprei dire perché –, in cui da una radio nuova che entra in famiglia la donna scopre casualmente di poter ascoltare, sistemando la sintonia, tutte le conversazioni del palazzo, di carpire la loro intimità, una cosa da cui si ritrae infelice ma che anche la attrae, non conosce gli inquilini, per lei sono dei fantasmi. Ormai non si trasmette quasi più nulla in media frequenza, e neanche in tutte le ore. Accendo l’apparecchio, attendo che le valvole si scaldino e poi provo a sintonizzarmi, tra fruscii e crepitii. Mi aspetto di poter sentire la voce di Paola, mentre intanto leggo Una radio straordinaria per l’ennesima volta, come fosse una sua traccia, una sua frequenza. Mi rendo conto di star scivolando verso una forma patologica della vedovanza – mi dicono di una vedova che porta al collo un’ampolla con un soffio di ceneri del marito, e chiama gli amici con il cellulare di lui e la sua rubrica, facendoli sobbalzare, e se telefoni a casa la segreteria, in sua assenza, risponde con la voce del defunto. Mi chiedo pure se esista una forma patologica della vedovanza – vedovo, viene dal latino viduus, letteralmente privo –, se esiste cioè una forma patologica della privazione, e non siano piuttosto gradi di condizione.
Caitanello Cambrìa, sprudente, si rivolge così a Nasodicane: «Eh, non te lo puoi inghiottire che appena appena sospiro e non finisco nemmeno di dire “Aci…”, e l’Acitana impavida, vera valorosa, non vede e non sente più niente, non ragiona più e per quanti guardiani tu le tieni a guardia e per quanto scuro e profondo, a quanto si dice, è il tuo regno sotterraneo, l’Acitana non puoi trattenere. E che le gettai? Un sospiro, ma per lei è come corda di bastimento, s’afferra alla cima e sale linda linda, mi sale qui, al fianco mio…». Caitanello ha rovesciato il mito di Orfeo. Non è lui a scendere nell’Ade – non sa neppure come sia, «a quanto si dice» è scuro e profondo – ma è Euridice, l’Acitana, a salire da lui. Gli basta gettarle un sospiro e quella si aggrappa come corda di bastimento. Certo, Caitanello non è un poeta, non ha una lira per accompagnare versi, possiede solo l’acutezza dello sguardo, capace di attraversare fate morgane e altre magie dello Stretto per individuare i branchi di pesce. Eppure, le sue nenie, le sue rabbie, i suoi dolidoli, i suoi impazzimenti di parola, cos’altro sono, se non poetica? Caitanello sta fermo, dritto nella sua camera che si è eretto a fortilizio come quando era a vedetta-fileri, lassù sull’albero del lontru. Ha chiuso le imposte e acceso un lume, stavolta non gli serve acutezza di sguardo ma sagacia di parola, per sprovare Nasodicane, per trattenere a sé l’Acitana.
Paola ha staccato la spina quando non ho più capito le sue parole. Non ha mai sentito dolore – fu la prima cosa di cui chiesi conto ai medici e mi rassicurarono, il coma epatico è progressivo ma non produce dolori e finché aveva sensi io continuavo a chiederglielo e lei mi diceva di no, di stare tranquillo, io poi per sicurezza gli ultimi giorni in cui non parlava le feci la morfina – ma deve avere provato un dolore immenso per non poter parlare. Una orribile candida le devastava il palato, le sue difese immunitarie erano azzerate dalla chemio, e il fegato in metastasi e in panne le impastava la bocca, prendeva solo dei liquidi o qualcosa di frullato, poi niente più, solo le flebo, ma soprattutto faticava enormemente a farsi capire, a pronunciare anche solo una richiesta. Per darle gli occhiali ci misi un buon paio di minuti a capire e così per un giornale di cui voleva leggere qualcosa – irritata mi fece segno di portare via tutto. Ogni tanto, nel delirio progressivo, mi diceva cose che a me sembravano senza senso, mentre lei inseguiva le sue preoccupazioni. Un giorno, in una delle momentanee lucidità, mi tranquillizzò, che lei non si stava annoiando, aveva modo di parlare con tanta gente che venivano a trovarla, erano i suoi fantasmi. Infine, provò a dirmi qualcosa, ma io non capivo, provò a ripeterla e io con lei, ma non era quello, allora tentò di nuovo con una fatica enorme, e io a quel punto dissi una cosa qualunque, che sì, di stare tranquilla, ci avrei pensato e avrei sistemato, lei mi guardò con aria interrogativa – non era quella la risposta giusta –, la mia finzione doveva esserle evidente, e tacque. Mi aveva fatto promettere che non mi sarei accanito per trattenerla, ma ha pensato a tutto da sola. Staccò la spina, si lasciò andare. Soffro tantissimo per questo, per non avere le sue ultime parole, e credo sia nulla rispetto il suo dolore di non poter avere parole ultime per me. La Morte ingoiando le sue parole si era istallata tra noi, arrogandosi il diritto di avere lei l’ultima parola, il silenzio, quella gran doppia buttana di Nasodicane.
«A ‘Ndrja Cambrìa, a sentire “Aci, Acire, Gala, Galatè, Aciga, ciga, cigala, ci-te, ci-tè, Ci-ci-ci-ci. Ciccicci, ciccicci, ciccicci”, le due voci si confondevano. Richiudeva gli occhi a sentirli: il sonno lo invadeva, e quel suono col sonno, quel “ciccicci”, quella gentile miserevole nullità del mondo, era come favoleggiasse qualcosa di stranamente, di indecifrabilmente, di potentemente persuasivo, di cui l’Acitana e Caitanello conoscevano il segreto. Gli pareva che quelle poche sillabe ricevessero ogni volta mille e mille variazioni di tono e di significato, girandosi e alternandosi, baciandosi e combaciandosi, isolate o a coppie, tutte e nessuna. Quante e quali cose trovavano da dirsi e quanti modi per dirsele, strani, impensati, senza senso, felici, anche se era sempre, una sillaba o l’altra, un modo o l’altro, sempre sempre, idem come sopra…». Mochi e Momi erano le nostre sillabe, il nostro “ciccicci”, un gioco infantile che avevamo cominciato da ragazzi e mai più smesso, che ci scambiavamo, a seconda del senso, del tono, della frase, del gesto, in una ritualità infinita. Finita, adesso. Talvolta, più colloquialmente era un “La”, e solo quando iniziava a dire “Lanfranco”, allora, mi stava arrivando un discorso, tra capo e collo. Non mi chiamerà più dalle scale per avere il suo caffè del mattino, non mi chiamerà più dal terrazzino mentre sono nel giardino a potare qualche pianta perché c’è piuttosto da riparare il manico di una pentola o una qualche anta, non mi chiamerà più perché è ora di andare a dormire e non crollare come un coglione davanti la tivvù, non mi chiamerà più scuotendomi perché c’è la luna piena e tra i rami della palma è meravigliosa a guardarla e «Alzati, cazzo, Mo’». Non mi chiamerà più, non la chiamerò più, non potrò più giocare con le nostre sillabe felici. Potrò, questo sì, ascoltare il mio nome, scandito o gettato lì. L’amore delle sillabe, l’infinita possibilità creata dalla miserevole nullità del mondo, il nostro segreto, però, quello, è perduto per sempre.
Ha avuto un funerale come dio comanda, il nostro dio, quello delle piccole cose. Certo, c’erano la bandiera rossa e quella del femminismo. Quando siamo usciti di casa, proprio sull’ultimo gradino sono cominciati dei fuochi d’artificio e sono durati fino al curvone, dove inizia la strada verso il cimitero. È stato un caso – era il giorno dei Santi Cosma e Damiano che si festeggiano in un quartiere del paese – ma in molti hanno creduto fosse stato voluto da noi. M’è sembrata una coincidenza davvero felice, come doveva andare. Siamo arrivati a piedi al cimitero, che è vicino, e gli ultimi metri dall’ingresso fino alla cripta le donne hanno voluto prenderla sulle loro spalle. È stata una cosa molto bella. C’era tutto il paese, forse di più, e gli immigrati di colore e le donne dell’est per le quali aveva messo su negli ultimi anni la scuola d’italiano. Il saluto che più mi ha commosso è stato quello del suo parrucchiere. Un ragazzone allegro che s’è presentato a casa nella sua pausa pranzo, prima del funerale. Aveva ancora addosso la sua maglietta di lavoro, con stampigliato il nome del negozio, e qualche ciocca di capelli attaccata. Tra venire e tornare dal grosso centro dove esercita, e dove accompagnavo Paola, s’è bruciato la pausa pranzo. Tra i tanti effetti collaterali della chemio, non aveva mai subito danni ai capelli. Guardava con tenerezza le altre donne che con lei facevano la chemio, quelle che portavano dei foulard. Una volta ne incrociammo una che invece esibiva la sua testa rasata, una giovane donna alta e molto bella. La guardò con ammirazione – misurandone l’eleganza. Prima di ogni intervento chirurgico andavamo dal parrucchiere anche se magari c’era stata solo pochi giorni prima e certe volte minacciava di saltare la chemio – che facevamo a chilometri di distanza – perché non si sentiva in ordine. Negli ultimi mesi non aveva più voluto tingersi i capelli – era una cosa che meditava da anni, e che solo adesso si era convinta a fare. Le stavano davvero bene, ora che dopo due o tre ricrescite e gli opportuni tagli si erano uniformati in un gioco di sale e pepe. È stato un grande omaggio alla sua femminilità e al suo stile, mai venuti meno, e non doveva mancare. Voglio bene a quel parrucchiere.
«A Caitanello, a suo padre, a prestargli orecchio, là, nella “camera per dormire”, la coda gli era rispuntata, cioè a dire, a furia di spremersi sopra quella veste viola e farsi sudare sangue nel palmo delle mani, a furia di scavare come un cane dentro le ossa insabbiate di quella siluette, a furia e furia di bramarla e sfantasiarla, da tutto questo impasto di sabbia e di polvere, di respiri e sudori, di desideri e di sangue, da questo impasto fangoso di gelo e di calore, di morte e di vita, gli era rispuntata dal fianco la moglie». Io sento solo dolore per tutto il fianco, come il senso di una mancanza, come si dice accada a chi perde un arto e però gli fa male quando cambia il tempo, magari sarà che non ho abbastanza sfantasìa. Ho le mani piene di carezze che non possono essere date e perciò vuote, le guardo senza capire a cosa possano servirmi ormai, ora che non ho presa sul mondo. Allungo le braccia nel vuoto, mi stringo al petto l’assenza, e provo a fare le figure del nostro ballo, quando nella “camera per dormire” o in quella per mangiare o dove capitava intrecciavamo i passi di una tarantella tutta nostra, per rabbonire il mondo delle nostre piccole cose, per rappacificarci dopo una rissa furiosa per un nonnulla, per augurarci una giornata buona. Non sempre funzionava, ma ci facevano ridere le pose che assumevamo – a volte era lei a iniziare, a volte io –, quel gioco dei corpi che senza toccarsi si infilavano uno nell’altro, si imitavano e si facevano diversi. Mi sento goffo e sgraziato e nessuna coda mi ricresce, restando qui alla deriva, scodato, sullo scill’e cariddi, preda delle correnti e dell’Orca.
«Dovremmo imparare l’arte di voltarsi», mi dice un’amica. Mi suona come un concetto molto bello, nell’ossessione di adesso all’immediato che ha sostituito l‘illusione del futuro. Le obietto che così però condanneremo Euridice, per sempre. E noi stessi. «È stata una loro scelta, quella, e non avremmo la poesia senza la perdita di Euridice, ricordati di Cocteau e della sua lettura di Orfeo», mi ribatte. Non so, forse quest’arte del voltarsi è destinata piuttosto a Euridice, ai ragazzi di Terrassa, a tutti noi quando andiamo di là, non prima, e qualcuno ci chiama. Platone – che certo non teneva in gran considerazione i poeti – era sprezzante verso Orfeo, che la menava un po’ troppo e poteva pure prendersi la briga di ammazzarsi, se davvero aveva tanta voglia di stare con Euridice. Confesso che trovo ragionevole la crudezza di Platone e di aver pensato che se avessi avuto la certezza intellettuale o la fede di rivederla e stare con lei per sempre, mi sarei ammazzato all’istante, le sarei corso incontro, altro che voltarsi indietro. Lei l’avrebbe fatto? Resto qui per ricordarla, perché così possa vivere ancora tra noi – è una cosa che si dicono sempre quelli che rimangono. Con più crudezza mi dico che se resto vivo rimango con lei, se muoio resteremo entrambi soli. Però, il fatto è questo, io non sono un poeta e neppure un buon abitatore del mito, parlo troppo, per l’una e l’altra cosa. Fossi almeno un pescespada puddicinedda! Sarei corso dietro la feluca dove stava colpita la mia fianchipieni, avrei battuto con il mio osso spadato contro l’imbarcazione o avrei provato a saltarci dentro per ricongiungermi a lei, avrei chiesto a Caitanello Cambrìa di colpire anche me col ferro della traffinera, di farmi la grazia. Avrebbe capito. Mi accingo a sopravvivere invece – le vent se lève, il faut tenter de vivre, scrive Valery in Cimetière marin –, e questo è tutto.
No, non è tutto. Ieri l’altro è nata Francesca, la figlia di mio figlio e della sua compagna. Le rappresentazioni che Julian Barnes utilizza per dire cosa si provava e cosa si provi – le ascese in mongolfiera e il precipitare sulla terra – sono pregnanti, solo che la vita a volte mescola le carte, a volte accade che prima si precipita a terra «da un’altezza di qualche centinaio di piedi, con una tale violenza da ficcarti in terra fino alle ginocchia» e poi si sale in mongolfiera verso il cielo.
Nicotera, 16 novembre 2013 |
 |
| [torna
su] |
 |
|
|