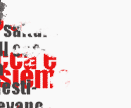|
|
|
14 Giugno 2013
Siamo poco credibili, poco affidabili, poco raccomandabili. Che virtù straordinarie, possediamo |

 La credibilità — uno dei quei lemmi chiave che sono stati usati con più insistenza nella costruzione recente del discorso della governabilità — è con tutta evidenza una questione relazionale. Di scambio. Come lo è la rispettabilità o l’affidabilità. Si è credibili nella considerazione di un altro, di altri, di un consesso d’altri. Nessuno è credibile certificando di per se stesso, in quanto portatore di una bastevole biografia — non è sufficiente “sentirsi” tale —, nessuno userebbe questo criterio di “identificazione” nella definizione di sé, da mettere accanto a dati incontrovertibili, all’altezza, al colore degli occhi, alla lingua, allo stato civile. La credibilità, ovvero l’essere portatori e cercatori di un “credito”, materiale e immateriale, e l’essere di converso considerati “solvibili”, moralmente e concretamente, è una sorta di voucher sociale, di “patente sociale” che si chiede e ti viene data dagli altri. Si è credibili perché tali siamo stati per altri e siamo definiti da altri, perché ad altri ne abbiamo dato prova in determinate circostanze, in ottemperanza a determinati parametri, perché abbiamo superato delle prove o perché ci stanno mettendo alla prova. La credibilità non si trattiene presso di sé ma si usa come moneta di scambio. La credibilità — uno dei quei lemmi chiave che sono stati usati con più insistenza nella costruzione recente del discorso della governabilità — è con tutta evidenza una questione relazionale. Di scambio. Come lo è la rispettabilità o l’affidabilità. Si è credibili nella considerazione di un altro, di altri, di un consesso d’altri. Nessuno è credibile certificando di per se stesso, in quanto portatore di una bastevole biografia — non è sufficiente “sentirsi” tale —, nessuno userebbe questo criterio di “identificazione” nella definizione di sé, da mettere accanto a dati incontrovertibili, all’altezza, al colore degli occhi, alla lingua, allo stato civile. La credibilità, ovvero l’essere portatori e cercatori di un “credito”, materiale e immateriale, e l’essere di converso considerati “solvibili”, moralmente e concretamente, è una sorta di voucher sociale, di “patente sociale” che si chiede e ti viene data dagli altri. Si è credibili perché tali siamo stati per altri e siamo definiti da altri, perché ad altri ne abbiamo dato prova in determinate circostanze, in ottemperanza a determinati parametri, perché abbiamo superato delle prove o perché ci stanno mettendo alla prova. La credibilità non si trattiene presso di sé ma si usa come moneta di scambio.
Credo sia importante tenere a mente questo aspetto della relazionalità, perché altrimenti la credibilità diventa — come spesso viene lasciato intendere nella costruzione del discorso della governabilità — una questione di “carattere nazionale”, di “identità nazionale”, un elemento antropologico. Quando morì Alberto Sordi — il cinema, nella costruzione di un racconto e di un immaginario popolare, ha avuto nel dopoguerra una straordinaria importanza, per come “ci si vedeva” e per come “si era visti” —, nella commozione e nel saluto generali, e nella considerazione per le sue capacità “mimetiche” di rappresentare sullo schermo virtù [poche] e difetti [tanti] degli italiani, si distinse Eugenio Scalfari — lo ricorda Silvana Patriarca in Italianità, Laterza, 2010 —, che scrisse: «una condizione umana tipicamente e inconfondibilmente nostra, composta da una mescolanza di difetti dai quali emerge poco meno che una etnia» [«la Repubblica», 26 febbraio 2003]. Poco meno che una etnia: la locuzione colta formalizza un senso comune diffuso di autorappresentazione e di rappresentazione altrui. E non importa qui contestare se siano vere o false. E se il “popolo italiano” — in un consesso europeo che vede nel discorso comune, nella costruzione del discorso comune, la credibilità tutta spostata verso il nord, dove il rigore e l’austerità anche per tradizioni religiose oltre che per ragioni climatiche [sic! c’è una lunga tradizione anche italiana di pensiero che collega clima e carattere] farebbero da supporto, e la poca o scarsa credibilità tutta concentrata nel sud, dove il lassismo e la perdonanza, anche per tradizioni religiose oltre che per ragioni climatiche farebbero da contorno — è costitutivamente, antropologicamente, storicamente poco credibile, diventa incontrovertibile che una élite vada investita del diritto/dovere di governarlo, di indirizzarlo sulla retta via. Una aristocrazia di competenze e tecnicità sovranazionali supplirebbe in credibilità nazionale, dato che la competenza è credibile perché attestata da incarichi e ruoli precedenti e la tecnocrazia è credibile perché porta con sé i criteri della scientificità, delle verifiche e delle controprove. [Suscita sempre ilarità la scoperta di intestarsi maldestramente masters, titoli universitari e quant’altro, però è un istinto comune quello di riverire “la professoralità” e quando si sta nella sala di aspetto di uno studio medico la prima cosa che fai per ammazzare il tempo è guardarti i titoli incorniciati alle pareti in bella mostra: è il fascino della luccicanza, dello shining, della tecnica].
Le domande quindi sono: chi sono “gli altri” presso i quali dovremmo risultare credibili? E anche: chi rilascia questa patente di credibilità e quali sono i parametri della credibilità? A quale scambio la “moneta” della credibilità sta partecipando?
Non sono domande qualunque, perché la credibilità non è una moneta di scambio equivalente, che tu puoi usare con chiunque ti relazioni, ovunque ti trova e in qualunque momento, senza rapporto con lo spazio e al tempo. “Gli altri”, cioè, non sono il mondo intero ma una parte precisa, specifica d’esso. Ciò che ti rende credibile presso l’uno può essere motivo di ostilità quando non di disprezzo da parte di un altro. Faccio degli esempi di riferimento a tre momenti storici: al nostro Risorgimento, momento fondativo della nostra patria e quindi, in un certo senso, della nostra “faccia”, alla Resistenza e al ruolo dell’Italia nella guerra fredda.
Mazzini da emigrato a Londra era abbastanza credibile, tanto da potere fare affidamento non solo sulla simpatia di ambienti politici e culturali ma anche sul sostegno di ambienti economici, eppure Mazzini aveva dato scarsa prova di affidabilità e credibilità, tentando più volte fallite insurrezioni, oltre che essere tecnicamente un “terrorista”; Garibaldi era molto credibile per il suo coraggio e la capacità di comando — era già un “eroe” — a livello internazionale dopo le sue avventurose gesta in Sud America, eppure anche lui veniva da una sconsolata serie di sconfitte e tecnicamente rimaneva un “latitante”; e lo stesso Cavour che pure tanto da fare si dava per mettere assieme l’Italia non era molto credibile, non tanto per la sua lungimiranza, integrità o fermezza quanto per la sua possibilità concreta di riuscire nell’impresa con quello staterello insignificante alle spalle e quei Savoia così “provinciali”. Eppure senza la credibilità concessa — il sostegno o la neutralità — delle potenze straniere l’Italia non si sarebbe mai fatta e per farla occorse forzare la mano, giocare alle tre carte, rabberciare assieme delle forze su cui nessuno avrebbe scommesso un centesimo, mettere il mondo di fronte il fatto compiuto come se non se ne sapesse nulla. Si può dire che una credibile idea d’Italia, un credibile discorso sull’Italia sia nato all’estero, che la credibilità che si costituisse una patria italiana sia un’idea maturata più “fuori” che “dentro”, che la mallevadoria di potenze straniere credibili abbia dato consistenza alla poco credibile forza risorgimentale nel paese.
La credibilità dei nostri uomini risorgimentali era inversamente proporzionale al discredito che i governanti, le monarchie che vi regnavano — il papato, i Borbone e gli austriaci — raccoglievano presso alcune potenze, non certo il mondo intero, e non altre che invece proprio quei regnanti discreditati consideravano inamovibili e affidabili: era, cioè, una questione di opzione internazionale. Per quella opzione internazionale — la Francia, l’Inghilterra —, l’Italia reale era un disastro, l’Italia potenziale era credibile. Con diffidenza e tutela, nello scambio politico. Va perciò sempre tenuta a mente la coppia credibilità/discredito: si può agire una propria credibilità solo se esiste e si agisce contemporaneamente un discredito. Si può essere credibili solo contrapponendosi a un discredito d’altri. O ancora: solo intercettando un discredito altrui già vigente, già consolidato.
Con la Resistenza le cose si complicano: la capacità militare delle nostre formazioni partigiane non era credibilmente in grado non dico di battere ma neppure inceppare la macchina tedesca e la capacità politica, la penetrazione e il radicamento sociale, non era credibilmente in grado di rovesciare il regime. L’intervento alleato, lo sbarco, l’avanzata segue una strategia militare e politica che prescinde dalla presenza delle formazioni partigiane [non fu così in Francia]; solo con l’avvicinarsi della fine della guerra il ruolo del Comitato di liberazione nazionale diventa credibile e spendibile — a volte malvolentieri e spesso con estrema diffidenza — in quanto potenziale, futura classe dirigente per dare un governo al paese, per accoglierlo nel consesso internazionale. Con tutela nello scambio politico.
Infine, nella guerra fredda, nella contrapposizione dei blocchi imperiali tra Ovest e Est, l’Italia, dove era insediato «il più forte partito comunista dell’occidente», godeva di credibilità atlantica proprio per quella presenza. Quanto più la presenza comunista aleggiava minacciosa, tanto più diventava credibile ogni possibilità di infragilirla — De Gasperi tornò dal viaggio negli Stati uniti con i cento milioni che salvarono il paese dando in cambio la cacciata dei comunisti dal governo; Saragat divenne uno “statista” con un pugno di ometti, perché guidò la scissione socialista di Palazzo Barberini; i socialisti ebbero accesso alla “stanza dei bottoni” solo quando si staccarono definitivamente dal frontismo con i comunisti; e infine Berlinguer non venne più dipinto come il diavolo quando accettò «l’ombrello atlantico» —, di intaccare il presente e mettere un’opzione sugli scenari futuri.
Il futuro perciò è il vero criterio della credibilità, essendo il passato, invece, il sedimento del discredito. La credibilità è un’opzione, non già una memoria consolidata. E non potrebbe essere altrimenti, perché ogni scambio è un’opzione sul futuro. Soprattutto, non è una memoria condivisa, e come tale non è nemmeno un futuro condiviso. La credibilità è una scelta di parte, una scelta politica di parte. La credibilità è un progetto, un investimento, un future, un’assicurazione, e come tale richiede delle pratiche da adempiere e degli investitori che vi scommettono sopra. Credibilità e solvibilità — rispetto delle pattuizioni di scambio — sembrano davvero intrecciati strettamente e indissolubilmente.
Sottolineo questo perché la credibilità internazionale dell’Italia si è progressivamente spostata, nella valutazione degli altri, da un criterio squisitamente politico nella sua storia — la formazione europea degli stati nazionali, la guerra al nazifascismo, la contrapposizione dei blocchi e la cortina di ferro —, in cui erano ben definiti e personalizzati i riferimenti, a un criterio in cui i riferimenti sono sfumati, oscuri e impersonali, i mercati. È vero che questo metro di misura è ormai quello vincente e vincolante, però non è esattamente così per chiunque e ovunque. Facciamo degli esempi: la Turchia è credibile solo per il suo straordinario progresso economico, o non anche perché il suo ruolo politico di stabilizzatore nell’area la rende fondamentale? E viceversa, il Giappone, la cui economia da più di vent’anni è in piena stagnazione, con un debito pubblico più spaventoso del nostro, non deve la sua credibilità internazionale ormai da tempo non più al made in Japan ma al fatto che la sua affidabilità “occidentale” serve da contrappeso all’espansione cinese? Chi potrebbe mai permettere il fallimento dell’economia giapponese? Voglio dire che sono vere entrambe le cose: i mercati economici giocano un ruolo politico e lo scambio politico ha un ruolo dominante nei mercati economici.
La credibilità internazionale dell’Italia è pari al suo ruolo nella geopolitica che, paradossalmente, era significativo — eravamo la portaerei americana nel Mediterraneo — nella guerra fredda ma si è progressivamente ridotto fino all’insignificanza quando la “minaccia comunista” è caduta rovinosamente insieme al muro di Berlino. L’Italia era credibile atlanticamente — era questo il suo mercato di scambio politico — anche e nonostante la sua partecipazione europea quando apparteneva a un “regno” americano, dentro il quale la propria sovranità era già fortemente limitata. L’appartenenza a questo regno era il passaporto di credibilità e solvibilità internazionale. Su questo credito politico il nostro debito economico poteva tranquillamente crescere a dismisura. Non ci avrebbero fatto fallire.
La credibilità economica era, al tempo della divisione dei mondi, subordinata alla solvibilità politica. Il debito pubblico, che era motore di consenso sociale, di distribuzione di ricchezza e di benessere economico, era la “faccia” della nostra solvibilità politica. Ma è qui che nasce la crisi del modello economico del nostro paese, non con la crisi dei subprime, il fallimento della Lehman Brothers o l’insolvenza dei titoli di Stato. La crisi del nostro modello economico basato sul debito pubblico è crisi politica. La nostra credibilità economica è rovinata insieme e a seguito dell’inconsistenza della nostra credibilità politica.
E oggi come stanno le cose? Leggiamo Franco Venturini, sul «Corriere della Sera»: «La credibilità internazionale dell’Italia è affidata da anni più alle sue missioni all’estero che alla sua politica estera».
È vero, non abbiamo da anni una politica estera, uno straccio di politica estera che segua un preciso interesse del paese, “orfani” della divisione dei mondi e del regno americano, e partecipi riottosi di un’Europa, questa Europa, che si è costruita sull’asse franco–tedesco, in cui non abbiamo mai contato davvero, mancando un nostro ruolo determinante, uno nostro scopo, una nostra mission, come accadeva in precedenza.
L’identità politica dell’Italia, quella da spendere sui mercati, quella da dare nello scambio politico, è perciò sempre più affidata agli “ingegneri della credibilità” — mutuo il termine da Giulio Bollati che parla di «ingegneria dell’italianità» in L’italiano, Einaudi, 1996 —, ai tecnici.
La credibilità è attualmente solo un discorso delle élites.
Non è sempre stato così, appunto. Minoranze credibili sono state nella storia del nostro paese in grado di intercettare momenti storici di cambiamento e forzarli verso un interesse generale, un nuovo patto sociale, un nuovo contratto politico nazionale.
Capaci di rendere credibile l’incredibile. Perché è nell’incredibile la speranza del cambiamento.
Nicotera, 24 aprile 2013 |
 |
| [torna
su] |
 |
|
|