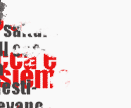|
|
|
16 Dicembre 2013
Avanti popolo, un forcone la trionferà |

 Quando sti forconi erano comparsi in Sicilia, un anno fa, sbucati dal nulla, gli avevano dato subito del “mafiosi” – era stato Ivan Lo Bello, l’azzimato presidente di Confindustria dell’isola, a lanciare per primo l’allarme e a seguire furono rispettabilissimi procuratori del proprio ordine e pagliette politiche di questo o quel partito. Quando sti forconi erano comparsi in Sicilia, un anno fa, sbucati dal nulla, gli avevano dato subito del “mafiosi” – era stato Ivan Lo Bello, l’azzimato presidente di Confindustria dell’isola, a lanciare per primo l’allarme e a seguire furono rispettabilissimi procuratori del proprio ordine e pagliette politiche di questo o quel partito.
Adesso, manco avevano fatto in tempo a rimettere fuori il capo che gli appiopparono subito del “fascisti”. Stavolta a lanciare l’allarme sono state le vestali della democrazia come fosse il proprio tinello di casa: sempre tirato a lucido da qualche filippina cui loro sovrintendono, un posto sacro dove raccomandano di non fare entrare gli estranei, i ragazzi delle consegne, gli zingari che ti bussano per l’elemosina, quelli che ti chiedono se hai già tutto il set completo dell’aspirapolvere, quello che viene a potare le piante, che tutti sporcano le piastrelle di ceramica e rubano – poverini, non lo fanno apposta, è la loro natura. La democrazia – dicono le vestali – è una cosa che ci vuole una sua finezza, non è che uno arriva, si siede a tavola e sbraga manco fosse casa sua.
Sta qui, in questo passaggio di consegne lessicale del giudizio dispregiativo – il “mafiosi” evocava un pericolo morale, benché virale e infiltrante, territorialmente circoscritto; mentre il “fascisti” evoca subito un pericolo politico, territorialmente dilagato –, la parabola di un anno del movimento dei Forconi o del Coordinamento 9 dicembre che dir si voglia. Perché loro dalla Sicilia sono partiti ma in tutta Italia sono arrivati, e questo – comunque la si voglia mettere – è prova provata di una modificazione, di una continuità, di una dinamica di un movimento.
Un anno fa, in Sicilia, piccoli trasportatori e agricoltori provocano il caos nella distribuzione e negli approvvigionamenti, con blocchi stradali nei dintorni di Palermo, di Catania, nel centro dell’isola, fino alle lunghe colonne all’imbarco dei traghetti a Messina. È subito scontro diretto, cinque giorni d’inferno, senza mediazioni, senza procedure, senza avvisi: o meglio, gli avvisi c’erano stati. Guardate che il giorno tal dei tali noi cominciamo a provocare il caos. Nessuno ci credeva, nessuno li prese sul serio. Invece, riuscirono a piegare l’isola. Non si trovava più benzina e gli scaffali dei supermercati diventavano rapidamente sempre più vuoti. Il livello dello scontro fu subito alto e non era facile reggere quella pressione, le provocazioni, le minacce, gli allisciamenti. Infatti, non la ressero, e si spaccarono presto, troppo presto.
Devono avere imparato però. I forconi, dico. A non lasciarsi circondare o rimanere inchiodati in un posto, a non cercare subito il livello alto dello scontro semmai arrivandoci gradualmente, a mollare tatticamente e poi riprendere, a diffidare dal fare il partitino politico in proprio [ci avevano provato, alle regionali siciliane, e è stato un bagno clamoroso]. Fanno discorsi disperatamente ragionevoli, hanno presto preso le distanze dalle azioni e dalle parole più provocatorie, più fasciste, via, non puntano alla prova di forza immediata e non cercano lo scontro diretto, si prendono tempo, cercano il passo lungo, sanno che non è cosa che si risolve in cinque giorni.
Insomma, sono politicamente cresciuti. O, se volete, sindacalmente. Il che, di sti tempi, sarebbe pure meglio.
Devi essere proprio trinariciuto per non capire che questo è un pezzo di popolo. E devi avere proprio le corna e lo zoccolo di capra per dire che se questo è un pezzo di popolo, allora è meglio starsene alla larga e tenersi le proprie certezze, il proprio tinello tirato a lucido, insomma. Che c’è un pericolo della destra. Io non credo – ne possiamo parlare – che ci sia una destra forte in Europa e in Italia, come quella degli anni Venti e Trenta, per capirci. Ci sono fascisti e nazisti, pre e post, brutali e balordi, ma la crisi della politica, del progetto, della visione, non è un privilegio solo della sinistra. Anche la politica, tutta la politica è indebitata.
Intanto, la linea della palma – come diceva Sciascia, a proposito della meridionalizzazione dell’Italia – è salita. Solo che stavolta è la linea delle lotte, dei tumulti. La meridionalizzazione delle forme di lotta è ormai prevalente, nel Nord-ovest e nel Nord-est, posti proverbiali, ormai mitici per le analisi dei sociologi da trent’anni in qua. Eppure, eccoli meridionalizzati. Erano i contadini siciliani che facevano fuoco e fiamme, venivano fucilati, perdevano, emigravano o ritornavano nei campi sotto la sferza e la lupara dei latifondisti e dei gabelloti. Così andava. Poi, dopo dieci, vent’anni, ritornavano a insorgere, loro stessi o i loro figli o i loro nipoti.
Poi venne il movimento operaio, la sapienza organizzativa, la capillare diffusione, la forza cooperativa di tenuta. Si perse l’aspetto messianico, ma si guadagnò in riforme e miglioramenti duraturi. Non furono rose e fiori, certo, tra il movimento operaio e le rivolte contadine, ma fu una battaglia politica epocale.
Ora, queste figure della produzione e della distribuzione – ambulanti, piccoli contadini, piccoli trasportatori – non sono neppure marginali, sembrano piuttosto dei sopravvissuti d’un tempo antico, premoderno, eppure invece hanno un loro ruolo, come sempre accade nei grandi passaggi epocali del cambiamento, che non sono dal giorno alla sera ma si prendono un gran tempo per essere definitivamente. Sono legati al territorio – il mercato dei quartieri, il pezzo di campagna, la distribuzione regionale – e pure nello stesso tempo sono nomadi, si spostano, vanno dove la domanda si raccoglie, li cerca, periferie. Periferie produttive, distributive. Al tempo di Wikileaks e degli hackattivisti, al tempo dei clic su internet per dire buuu ai potenti o decidere un qualche thread, al tempo dei retweet delle dichiarazioni dei politici, cioè al tempo della smaterializzazione delle lotte, e forse pure delle coscienze, da una storia “antica” irrompono i forconi.
Sono indebitati, tartassati, i margini dell’evasione fiscale e dell’illegalità distributiva – che in questa “zona sopravvissuta” magari era tutta l’origine del loro profitto – si vanno restringendo. Sono i più esposti, in prima linea nell’indebitamento generale, quello di artigiani, piccoli esercenti, pensionati, pezzi di popolo, insomma.
Mettere assieme il “popolo indebitato” non è impresa facile. Relativamente più facile è ancora far resistere il pubblico impiego, gli operai, quelli insomma che si riconoscono per avere in comune un posto produttivo, un ruolo “pubblico” nell’immaginario sociale, una categoria, un sindacato, un linguaggio che la società forse non parla più ma ha parlato insieme e tiene memoria della grammatica. Qui, invece siamo nel “privato”. Sembra un paradosso, ma è così: il popolo si presenta come un dispiegamento di “lobby pubbliche” e un coacervo frammentato di “privati indebitati” – non c’è più la prevalenza di una forma di lavoro che diventa paradigma delle angosce e delle richieste collettive. Forse la Camusso non ha tutti i torti quando parla di un’oggettiva inconsistenza attuale dello sciopero generale, di una sua “esclusività” che non intercetta tutto il “popolo produttivo”.
Io dico: intanto che aspettiamo che il lavoro maturi nuove forme della lotta e della resistenza, dei luoghi dell’organizzazione, delle riforme da chiedere e dei sabotaggi da produrre, intanto che aspettiamo il postmoderno movimento operaio, teniamoci le sue primitive manifestazioni. Affianchiamole, aiutiamole, ragioniamoci, litighiamoci. Se uccidiamo queste, non avremo le evolute. Mi sa che pure in natura funziona così.
Nicotera, 16 dicembre 2013 |
 |
| [torna
su] |
 |
|
|