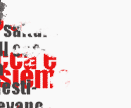|
|
|
02 Settembre 2013
Yankee, come back |

 Quando, nel 2009, fu assegnato il premio Nobel per la pace a Obama, in molti storsero il naso: cosa aveva fatto per meritarselo? Sembrava più un gesto retorico che il riconoscimento di un impegno per risolvere i conflitti e i focolai di guerra nel mondo. Obama era stato eletto presidente da poco più di un anno e si trovava ancora a gestire l’eredità guerrafondaia del suo predecessore. Eppure, il premio era un “investimento” che faceva leva proprio sull’opposizione alla guerra in Iraq [a dumb war, l’aveva definita, una guerra stupida] e la promessa di un disimpegno dall’Afghanistan che avevano portato il giovane senatore democratico a correre e vincere per la Casa Bianca. Obama, insomma, rimetteva in discussione l’impero americano e il suo ruolo di global cop, di poliziotto del mondo, e gli “aggiornamenti” fra Clinton e Bush con guerre umanitarie, esportazioni della democrazia, shock and awe. I membri dell’Accademia di Svezia dovevano essere fra i tanti convinti che negli ultimi sessant’anni l’America le avesse più provocate che prevenute, le guerre. Dovevano essere, insomma, fra i milioni che nel mondo, per decenni, avevano gridato: Yankee, go home. Ecco, ora Obama sembrava promettere proprio questo: okay gente, ce ne staremo per i fatti nostri. E quale migliore dimostrazione, questa, di un suo duraturo impegno per la pace, anzi di una possibile pace universale? Se l’era guadagnato, perciò, il Nobel per la pace, eccome. Quando, nel 2009, fu assegnato il premio Nobel per la pace a Obama, in molti storsero il naso: cosa aveva fatto per meritarselo? Sembrava più un gesto retorico che il riconoscimento di un impegno per risolvere i conflitti e i focolai di guerra nel mondo. Obama era stato eletto presidente da poco più di un anno e si trovava ancora a gestire l’eredità guerrafondaia del suo predecessore. Eppure, il premio era un “investimento” che faceva leva proprio sull’opposizione alla guerra in Iraq [a dumb war, l’aveva definita, una guerra stupida] e la promessa di un disimpegno dall’Afghanistan che avevano portato il giovane senatore democratico a correre e vincere per la Casa Bianca. Obama, insomma, rimetteva in discussione l’impero americano e il suo ruolo di global cop, di poliziotto del mondo, e gli “aggiornamenti” fra Clinton e Bush con guerre umanitarie, esportazioni della democrazia, shock and awe. I membri dell’Accademia di Svezia dovevano essere fra i tanti convinti che negli ultimi sessant’anni l’America le avesse più provocate che prevenute, le guerre. Dovevano essere, insomma, fra i milioni che nel mondo, per decenni, avevano gridato: Yankee, go home. Ecco, ora Obama sembrava promettere proprio questo: okay gente, ce ne staremo per i fatti nostri. E quale migliore dimostrazione, questa, di un suo duraturo impegno per la pace, anzi di una possibile pace universale? Se l’era guadagnato, perciò, il Nobel per la pace, eccome.
Obama non ha mantenuto tutte le sue promesse: Guantanamo, a esempio, non ce l’ha fatta a chiuderla. Però, è vero, ha onorato la parola di tirare fuori l’America dalle guerre in cui era impantanata: ha ritirato i soldati dall’Iraq, secondo gli impegni programmati, e ha fatto rientrare soldati quanti più possibile dall’Afghanistan, sostituendo the boots on the ground, gli scarponi sul campo con i droni nel cielo. In Libia, ce l’hanno messo in mezzo francesi e inglesi — i repubblicani gli facevano la salsetta, dicendo che svolgeva un ruolo di leading from behind, di guida dalle retrovie — e solo quando era ormai chiaro che Gheddafi avrebbe fatto una carneficina dei rivoltosi di Bengasi. E anche lì, comunque, niente uomini sul campo, se non un lavoro di intelligence, e tanto bombardamento dal mare e sempre droni. I droni sembravano la manna dal cielo, la soluzione tecnologica a un’impasse politica: niente più bare a stelle e strisce ma non è che siamo a “tana, liberi tutti”. In Egitto, ha subito aperto a Morsi e ai Fratelli musulmani, e non era scontato per nulla, e ha insistito a lungo col generale al Sisi, quando le cose sono degenerate, perché evitasse un bagno di sangue [si racconta che fra Chuck Hagel, sottosegretario americano alla Difesa, e il comandante dell’esercito egiziano siano intercorse ben diciassette telefonate in un solo giorno]. Certo, non si è stracciato le vesti per la repressione in Bahrain e neppure per lo Yemen, ma l’uno e l’altro sono sostanzialmente delle basi americane, e non si poteva mettere i bastoni tra le ruote dell’Arabia saudita o degli Emirati che sono fra i più fedeli alleati. E non si era sbilanciato, a parte qualche generica dichiarazione, neppure durante la rivolta in Iran, ma come poteva se proprio ai persiani era rivolto uno dei suoi discorsi più ispirati, quello in cui si augurava che «we will extend a hand if you are willing to unclench your fist», stenderemo la mano se voi aprirete il vostro pugno?
Farsi coinvolgere nei conflitti del mondo, far divampare le guerre non sembra più un buon affare, fosse pure perché il bilancio federale è in profondo rosso e il keynesismo di guerra di Bush e dei neocon — l’impegno militare come leva per la ripresa economica — si è dimostrato un buco nero di fondi statali e basta. E come dargli torto? Dopo più di dieci anni l’Iraq è ancora un disastro e ormai campo di battaglia fra sunniti e sciiti e l’Afghanistan forse di nuovo nelle mani dei Taliban e delle guerre tribali. Ma quella teoria che aveva guidato gli americani per tutto il Novecento — è un figlio di puttana, ma è il nostro figlio di puttana —, per cui avevano appoggiato macellai di ogni risma purché fossero di freno al comunismo, sembrava finalmente dismessa: il sostegno, o la mancata disapprovazione, dato alla fine dei regni di Mubarak e Gheddafi — i nostri figli di puttana contro il nuovo nemico, il fondamentalismo — sta lì a dimostrarlo.
Insomma, come ha detto schiettamente John Kerry, segretario di Stato, «l’America è stanca della guerra». E questa è davvero una buona notizia. Per noi e per la Storia.
E guarda un po’ che succede adesso. Che di fronte alla guerra in Siria il mondo occidentale, mentre strepita contro il macellaio che stermina il proprio popolo, si tira fuori da qualsiasi impegno e chiede agli americani di farlo loro, il lavoro sporco. Così, tutte le democrazie si rimandano a una qualche deliberazione dell’Onu, che tanto non ci sarà mai, a una qualche soluzione politica e diplomatica che non si capisce bene quale potrebbe essere e come realizzarsi, a un qualche voto dei parlamenti per una decisione che coinvolga la propria nazione, ma premono perché Obama abbandoni questa dannata prudenza e metta finalmente l’elmetto. Come ha detto Obama nel discorso in cui ha chiesto al Congresso di pronunciarsi sull’intervento in Siria, privately molte nazioni sostengono l’intervento. Insomma, il paradosso è che ora tutti vorrebbero che Obama si comportasse come Bush, magari non proprio, ma quasi. Il paradosso è che nessuno voleva un’America guerrafondaia però senza l’America in guerra nessuno è adesso in grado di fare qualcosa per mettere fine a guerre odiose. Fa bene, Obama, a chiedere a quelli che lo sostengono in privato di metterci la faccia, come fa lui.
E fa bene a chiedere al Congresso americano — pur mantenendosi la libertà di decisione in ultima istanza — di pronunciarsi: la guerra ritorna alla decisione politica, al dibattito pubblico parlamentare.
Non lo fa per salvare la faccia, come sostiene la più parte dei commentatori, quasi impigliato dalle sue stesse parole di monito alla Siria. È che sta diventando forte la percezione che il mondo dopo l’89, dopo la divisione bipolare tra russi e americani, sta precipitando nella frammentazione e nel tribalismo. Si muore molto di più oggi per via delle guerre di quanto accadesse solo vent’anni fa. Il consolidamento di una pluralità di potenze — la Cina, l’India, la Russia — moltiplica il potere di veto senza potenziare la capacità di soluzione per la pace, l’Europa è ancora come tra le fumanti rovine del dopoguerra, cioè un assieme di nazioni senza una voce politica unica, il Medio oriente e il Nord Africa vanno implodendo — tra rivalità etniche e guerre religiose — in schegge di fuoco che possono arrivare ovunque. Non è solo questione della Siria. E non siamo diventati più liberi, dopo esserci liberati di tanti dittatori e macellai. Nessuno, insomma, può imporre la propria volontà al mondo, nessuno è in grado di intervenire in un qualunque conflitto interno.
Tranne l’America, forse. Ma l’America è sola; dopo l’11 settembre una politica scriteriata, guerrafondaia è riuscita a isolarla. E the coalition of the willing, la coalizione dei volenterosi si è mostrata per quel che è, una manica di politici vigliacchi, buoni a fare gli umanitari col culo degli altri. È di questo che Obama vuole che gli americani parlino e sappiano, per decidere.
Yankee, come back.
Messina, 2 settembre 2013 |
 |
| [torna
su] |
 |
|
|