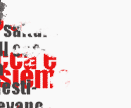|
|
|
06 Dicembre 2011
Così viviamo adesso |

 E la nave va E la nave va
I primi segni, come sempre accade con i segni veri che anche un’anima semplice li decifra e li incatena a una spiegazione logica e non serve saggezza antica per leggerli e capirli, parvero folgoranti.
Quel punto del Tevere che volge al tramonto, dove il letto del fiume, dopo aver corso placido tra seni e golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare delle sponde, quasi a un tratto viene a mancare, e si forma un salto e le sue acque come impaurite accelerano e ribollono, per poi ripigliare a distendersi, allontanandosi di nuovo e rallentandosi, e il ponte, che ivi congiunge le due rive, vi è rotto come a render ancor più sensibile all’occhio quella trasformazione, si affollò di topi.
I topi venivano all’aperto per morire.
Ratti mostruosi, sorci orribili e zoccole grosse un chihuahua da borsetta, che da sempre infestano le fogne e le sponde del fiume, le case del centro storico e quelle oltre il Raccordo anulare, le tangenziali e i vicoli, i ministeri e gli attici, le chiese e i monumenti, contendendoli agli uomini, strafottendosene beatamente degli uomini quando non minacciandoli, cercavano l’aria aperta e schiattavano. Dal fiume risalivano verso i giardinetti delle piazze, dove si affollano madri petulanti e bambini afflitti, tossici locali e spacciatori foresti, pensionati catatonici e badanti energumene. Fuggivano da cantine, muri, palazzi, uffici, scuole, caserme, cucine e ospedali, dove da secoli, da millenni prosperano e si riproducono, rivendicando un dominio più antico dell’Impero, più duraturo d’ogni regno, d’ogni repubblica, d’ogni governo. Piazza Savelli, delle Cinque scole al ghetto, Cairoli, largo Argentina, Sant’Andrea della Valle, Campo dei fiori, gli slarghi immediatamente vicini al ponte Rotto, era tutto un ribollire di sorci. Quando non ce la facevano ad arrivare alle piazze dove si accumulavano in orribili cataste – quasi avessero scelto per imperscrutabile istinto di concentrarsi e mostrarsi in moltitudine, come una manifestazione di massa –, morivano isolatamente o a gruppetti sulle strade. Lì venivano spiaccicati sull’asfalto e sui sampietrini dalle automobili, dalle moto, dai taxi, dagli autobus, dai pullman dei turisti sightseeing, che tanto arrotano tutto, pure i cristiani. Uno schifo immane, indicibile. Un’apocalisse nel cuore della cristianità.
E uno.
Fu la festa dei gabbiani. Il paradiso dei gabbiani. Riempivano l’aria dei loro uha-uha-uha-uha e yah-yah-yah-yah e planavano felici a banchettare. Non c’era neppure bisogno di contendersi la preda, tanta la schifezza da beccare, in abbondanza. Dei gabbiani, all’inizio i romani furono contenti. Per idem sentire, l’Ama, il servizio municipale di nettezza urbana sempre sull’orlo del fallimento ma lauta mangiatoia per i suoi dirigenti, non ce l’avrebbe fatta a pulire, per non dire che dopo neppure mezz’ora che avevano spazzato e lavato le carcasse di topi si riaccumulavano in un flusso inarrestabile. I gabbiani tornavano utili.
Almeno all’inizio. Ci si accorse presto dell’effetto collaterale: i gabbiani scacazzavano continuamente e abbondantemente sulle automobili, sui passanti. E sono cacche acide, perforanti, macchiose, che non portano alcuna fortuna a chi ne è investito. Divenne un’abitudine, quella di uscire con l’ombrello, benché a quel tempo si fosse quasi in estate, o con quegli impermeabilini trasparenti che i turisti mettono in borsa per gli improvvisi acquazzoni.
All’improvviso, cominciarono a morire pure i gabbiani. Prima, per l’ingordigia s’erano fatti grassi e non riuscivano più a volare: sembravano galline pigolanti o papere starnazzanti, muovevano un po’ le ali come dovessero spiccare il volo, ma tutt’al più andavano a sbattere contro qualche vetrina. Poi, quelli che riuscivano a sollevarsi, fatto solo un giro, crollavano dal cielo, abbattendosi sui terrazzi, sui balconi, sui tavolini all’aperto. Sulle strade. Divennero preda delle automobili, delle moto, dei taxi, degli autobus, dei pullman dei turisti sightseeing, che tanto arrotano tutto, pure i cristiani. Uno schifo immane, indicibile. Un’apocalisse nel cuore della cristianità.
E due.
A quel punto, la popolazione cominciò a temere e a interrogarsi se non fosse scoppiata una qualche epidemia, o stesse per arrivare. Gruppi di cittadini, sempre più numerosi, si affacciarono sulla piazza del Campidoglio, intorno al finto Marc’Aurelio, chiedendo risposte e rassicurazioni. In breve divenne una folla, che stazionava rumoreggiando. Il Reuccio – ormai per tutti era così, un po’ per la statura, un po’ per un’irrefrenabile attitudine all’assolutismo, un po’ per la passione alle donne e alla chanson che ricordava quell’altro di reuccio, quello trasteverino – non mise tempo in mezzo e si diede subito alla folla.
Apparve radioso nel suo accappatoio bianco che da qualche tempo era diventata la sua mise abituale e non la dismetteva mai, di giorno e di notte, nelle riunioni del Gran Consiglio, alle conferenze stampa o agli incontri dei Grandi della Terra. Le gazzette del giorno dopo – ma già, di subito, le agenzie – dissero meraviglie di quell’accappatoio e della sua luminosità: descrissero minuziosamente il drappeggio da tunica e la cintura con fregi d’oro paragonandola a un laticlavio, enfatizzando il ritorno di costumi – o tempora o mores – degli antichi senatori. Lui, il più senatore di tutti.
Disse che la natura stava compiendo il suo corso, che il peggio era ormai alle spalle, che solo i malintenzionati potevano insistere sulle difficoltà del momento. La folla si disperse.
Il giorno dopo, scomparvero gli zingari.
Non ce n’erano alla Stazione Termini e alle fermate della metro, di quelle femmine grasse con denti d’oro e lunghe sottane che ti volevano vendere a tutti i costi cornetti di plastica contro la malasorte o leggere la mano e il futuro e insistevano e ti tampinavano e maledivano in quella lingua sopravvissuta. Non ce n’erano di quelle ancora acerbe e già sfatte con neonati abbrancicati e fasciati intorno al corpo e circondate da mocciosi laceri in un avviluppo mostruoso da cui uscivano mani pronte a ghermire e rubare. Non ce n’erano di quelli giovani e scabri e agili che si arrampicavano per grondaie e tubi a entrare negli appartamenti e violarci il sonno e i beni. Non ce n’erano a rovistare tra cassonetti, a recuperare le cose nostre rotte, dismesse, per rivenderle come vintage a noi stessi su qualche banco di Porta Portese. Non ce n’erano a entrare nei negozi a fregare una qualsiasi cosa o ai Fori a dar disturbo ai turisti per distrarli e sfilargli denari e portafogli. Non ce n’erano di ancora bambini tra i vialetti dell’Eur o a Valle Giulia a prostituirsi di notte. Non ce n’erano da bestemmiargli dietro, da evocarli come colpevoli d’ogni danno, da spostarli sempre più lontano – per umanità, s’intende – o da andarci nei loro campi a bruciarli – sempre per umanità, s’intende.
Gli zingari erano scomparsi. I campi erano vuoti, abbandonate le baracche lungo il fiume. Per istinto di millenni, quando avevano visto i topi risalire verso la morte erano scappati. Non c’era più uno zingaro in tutta la città. Un altro segno.
E tre.
Stavolta nessun cittadino invase il Campidoglio e si strinse intorno al finto Marc’Aurelio per avere risposte e rassicurazioni. E il Reuccio non si affannò a spiegare. Nessuno zingaro valeva un accappatoio. E poi era stato già detto tutto: la natura compiva il suo corso. La nave andava.
Così era Roma, al tempo della crisi.
(segue)
Così viviamo adesso, Lozzi Publishing, collezione Remo
Ascolta l'intervista con Loredana Lipperini a Fahrenheit:
http://www.lanfranco.org/audio/rai_fahre_25_01_2013.mp3 |
 |
| [torna
su] |
 |
|
|