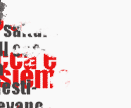|
|
|
20 Dicembre 2012
Potere e territori nelle Repubbliche e nelle Costituzioni del 1647 e del 1799 a Napoli |

 Non è necessario riuscire per perseverare Non è necessario riuscire per perseverare
Guglielmo d’Orange
Il 6 febbraio 1947, Meuccio Ruini, presentando all’Assemblea Costituente il progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione incaricata di cui era il presidente — c’erano, tra gli altri, Basso, Calamandrei, Di Vittorio, Dossetti, Einaudi, Fanfani, Finocchiaro Aprile, La Pira, Lussu, Moro, Mortati, Rossi, Taviani, Terracini e Togliatti, insomma, davvero una summa di autorevolezza, competenza, e rappresentanza sociale di quel tempo —, disse: «Formulare oggi una Costituzione è compito assai grave. Dopo le meteore di quelle improvvisate nella scia della rivoluzione francese e delle altre del Risorgimento, concesse dai sovrani — tranne una sola luminosa eccezione, la costituzione romana di Mazzini, alla quale noi ci vogliamo idealmente ricongiungere — è la prima volta nella sua storia, che tutto il popolo italiano, riunito a Stato nazionale, si dà direttamente e democraticamente la propria costituzione»[1]. Meteore, l’espressione usata da Ruini per repubbliche e costituzioni di pochi mesi — o «di un sol giorno», come recita il titolo del libro di Ugo Riccarelli dedicato alla Repubblica romana del 1849 — dà il senso della caducità di quelle esperienze, rapide e effimere. Il riferimento di Ruini alla dispersa nazionalità italiana “finalmente” riunita tutta in stato unico mette però anche in controluce la territorialità circoscritta di quelle stesse esperienze, ne sottolinea il confine come un limite[2]. A questa provvisorietà costitutiva di tempo e spazio possono anche accostarsi la Carta della repubblica del Carnaro, ovvero della Libera Città di Fiume, del 1920, sia nella versione di Alceste De Ambris, sindacalista dell’Estrema e poi antifascista esule[3], che in quella più elegiaca del “Comandante” D’Annunzio, che le varie repubbliche partigiane nate durante la guerra di liberazione dal nazifascismo. Il costituzionalismo moderno, che pone come sua data di nascita il 1776, anno della Costituzione degli Stati uniti d’America, le definirebbe “petites constitutions”, per significare quel senso di transitorietà e provvisorietà, di frammento[4]. E invece è proprio questa relazione provvisoria tra territorio circoscritto e costituzione — negli animi e nelle idee dei costituenti transitoria verso una più ampia e estesa nazionalità e cittadinanza — che qui si intende porre come questione. Ci interessa insomma far risaltare in rilievo la storia e il lavoro del territorio che si dà costituzione, che si fa costituzione. Che è un lavoro lungo, anche se le sue forme sono brevi. In questo senso, si è scelto di soffermarsi sulla storia costituzionale di Napoli. A partire dalla ribellione all’Impero spagnolo della Napoli del 1647, che il costituzionalismo moderno escluderebbe e che invece, a mio parere, appartiene per intero a quel “sogno di repubblica” che dalle Fiandre al Portogallo, dalla Catalogna a Napoli attraversa tutto il Seicento, con l’apparire di nuove forme di produzione e commercio, di nuovi soggetti sociali che non si riconoscono più nel potere monarchico e cercano diverse forme di rappresentanza del potere politico e dei suoi equilibri, e che si riverserà nel secolo successivo, per finire alla Repubblica napoletana del 1799. Due “picchi storici” nello stesso territorio, apparentemente speculari l’uno all’altro: nel primo una rivolta tutta “interiore”, che tende a esportarsi, nell’altro una rivoluzione che si appoggia all’“esteriore”, che tende a importare. I fili della storia — è il senso di questo testo — si riannodano sempre in certi momenti: nei “capitoli”, nelle carte, nelle costituzioni che vennero redatte, nella drammaticità e nell’intensità degli eventi che occorsero attorno la ribellione di Napoli del 1647 e la Repubblica napoletana del 1799 si rintracciano dei lasciti e dei rimandi che ancora oggi sono, a mio avviso, stelle comete sul percorso dell’indipendenza e dell’autonomia nel governo dei territori. Sono proprio questi due aspetti — potere e rappresentanza territoriale, oggi diremmo: democrazia e territori — che qui vengono messi a fuoco. Per riannodare i fili un’altra volta.
«La più illustre e ammirevole colonia del mondo»
Quando il cardinale Filomarino — che durante tutti gli eventi della ribellione napoletana del 1647[5] mantenne una propria autonomia e svolse spesso un ruolo di mediazione —, di fronte alla piega repubblicana che veniva assumendo tra i popolani riuniti intorno Gennaro Annese la rottura con la corte di Spagna, volle invece mostrarne l’impossibilità e argomentare ancora a favore di una riforma monarchica, che era la posizione fino allora maggioritaria propugnata da Genoino[6], si rifece al Machiavelli. Nei Discorsi sopra la Prima Deca di Tito Livio, il grande toscano era stato drastico nei riguardi di Napoli: «Pertanto dico che nessuno accidente, benché grave e violento, potrebbe ridurre mai Milano o Napoli liberi, per essere quelle membra tutte corrotte»[7]. E spiegava perché: «Dico che gentiluomini sono chiamati quelli che oziosi vivono delle rendite delle loro possessioni abbondantemente, senza avere cura alcuna o di coltivazione o di altra necessaria fatica a vivere. Questi tali sono perniziosi in ogni repubblica ed in ogni provincia; ma più perniziosi sono quelli che oltre alle predette fortune comandano a castella, ed hanno sudditi che ubbidiscono loro. Di queste due spezie di uomini ne sono pieni il regno di Napoli, Terra di Roma, la Romagna e la Lombardia. Di qui nasce che in quelle province non è mai surta alcuna repubblica né alcuno vivere politico; perché tali generazioni di uomini sono al tutto inimici d’ogni civiltà»[8]. Se mai fosse stato necessario, in quei giorni, in quei momenti, avere un quadro storico–sociale, un filo di analisi che spiegasse la lacerazione delle contraddizioni, quelle pagine erano di straordinaria attualità: erano i baroni, i loro privilegi, l’immutabilità del loro potere, il loro feudalesimo e il progressivo infeudamento del regno, “la” questione. Per Filomarino, e una parte consistente dei riformatori, il modo di affrontarla e risolverla era rafforzare il rapporto di Napoli con il potere centrale spagnolo a scapito delle resistenze baronali che, invece, su un equilibrio di relative autonomie, di cui il vicereame era perno, fondavano il loro potere. Era sostanzialmente una rivisitazione del “progetto campanelliano”, del Campanella di prima della utopica e rivoluzionaria Città del sole: la spagnolizzazione del mondo come unica garanzia di autonomia delle province dell’Impero. Per quel partito che, dopo l’uccisione di Masaniello, si stava progressivamente spostando verso l’indipendenza, la questione invece si poneva altrimenti: dopo le rivolte della Catalogna e dei Paesi Bassi, solo la repubblica avrebbe garantito la salvezza. La cosa straordinaria è che quelle pagine del Machiavelli furono stampate e diffuse nella città, alimentando il confronto e il dibattito tra la cittadinanza, in un clima di fervore rivoluzionario. Era, come in tutti i momenti rivoluzionari, un periodo avido di pensieri, di idee, di teorie, con una circolazione incredibile di documenti: il Manifesto del fedelissimo popolo di Napoli, pubblicato il 17 ottobre 1647, con cui si prendeva atto dell’irriducibilità della Corona alla riforma e si poneva di fatto la questione dell’indipendenza nazionale fu diffuso, oltre che largamente a Napoli, in tutto il resto d’Europa: lo si ritrova negli archivi e nelle biblioteche più importanti del continente. E d‘altro canto, il “modello delle Fiandre” era già, in vari modi, un riferimento a Napoli: numerosi reduci dalle imprese militari che avevano vissuto direttamente l’espansione coloniale e il grande sviluppo della marineria delle Province Unite parteciparono alla rivoluzione del 1647, dando notizie di prima mano, e la storiografia, la pubblicistica e la diplomazia avevano subito diffuso in Italia informazioni e giudizi sui Paesi Bassi.
L’episodio iniziale della rivolta — com’è noto — era accaduto la mattina del 7 luglio 1647, nella piazza del Mercato a Napoli, per un parapiglia nato intorno al pagamento di una gabella sulla frutta tra quelli che portavano i prodotti dalle terre vicine e i gabellieri. La protesta divampò subito acquisendo una dimensione più ampia e mettendo sotto accusa la politica del governo, con l’assalto al palazzo del viceré, il duca d’Arcos, di una massa di «gente furibonda e armata di ogni tipo di armi». In un tempo rapidissimo, precipitava e si intrecciava l’esasperazione degli strati inferiori della popolazione, la diffusione di sentimenti antispagnoli, le critiche di molti esponenti del ceto civile, intellettuali, mercanti, artigiani, e di alcuni rappresentanti della nobiltà. C’erano state altre ribellioni, ma questa volta la sollevazione si presentò immediatamente come un movimento generale. In pochi giorni, alla protesta seguì l’organizzazione delle milizie popolari — furono 114.000 i cittadini armati, per una città che contava allora, escluso i casali, 320.000 abitanti — che ricalcarono la struttura delle Ottine, ovvero dei quartieri della città, in cui i reduci delle guerre combattute divennero i capi militari: in un giorno furono formate «cinquanta bellissime compagnie», e le rivendicazioni politiche assunsero la forma delle «capitolazioni», ovvero di una nuova legge costituzionale. Spiccano, tra le norme: l’attribuzione ai capitani delle Ottine del potere di creare l’Eletto del popolo e altre norme sulla gestione autonoma del Seggio popolare; la parificazione dei voti tra nobili e popolari nel governo cittadino; il diritto del popolo di restare in armi fino alla ratifica regia dei capitoli; il concorso dei rappresentanti popolari, insieme a quelli della nobiltà, all’elezione del “grassiere”, cui spettava il governo dell’economia della capitale; l’esclusione dal «voto nella cosa pubblica» dei profittatori; la libera vendita dei viveri in tutti i luoghi pubblici.
All’elaborazione dei capitoli del 13 luglio parteciparono in primo piano esponenti delle città e dei villaggi più vicino a Napoli, ma la sollevazione popolare stava ormai dilagando in tutto il Regno. Le 12 province in cui era diviso il Regno — Terra di Lavoro, Principato Citra e Ultra (corrispondente all’incirca alla Campania attuale), Terra d’Otranto, Terra di Bari e Capitanata (Puglie), Abruzzo Citra e Ultra, Contado di Molise, Basilicata, Calabria Citra e Ultra — erano da tempo in grande tensione: i nodi di conflitto stavano nei rapporti tra amministrazioni municipali (Università) e baroni e tra i diversi ceti sociali rappresentati nei governi municipali. Artigiani, bottegai, lavoratori manuali erano esclusi dal governo, cui invece partecipavano, oltre terrieri e redditieri (i “gentiluomini” di Machiavelli), dottori, mercanti, esponenti degli strati superiori del popolo. Quando il governatore — perseguendo una blandura nei confronti della sollevazione, intanto che aspettava le armi spagnole per stroncarla — diede l’ordine di estendere il provvedimento di abolizione delle gabelle nelle province, non immaginava minimamente la valanga che avrebbe provocato. Il governo aveva sempre perseguito l’indirizzo di mantenere separate province e capitale, ma i capi della sollevazione, al contrario, si mossero sulla linea di una comunanza della causa. Anche le altre “voci” dei capitoli del 13 luglio vennero lette, nelle province, come direttive da rendere immediatamente pratiche. Così, la proclamazione della parità tra popolo e nobili divenne un punto di riferimento per le amministrazioni cittadine e per i loro Statuti, e si propose che anche i Comuni feudali fossero rappresentati nel Parlamento nazionale e che la procura fosse data soltanto a «persone popolane». Da Napoli, i capi popolari spingevano perché tutte le province del Regno venissero coinvolte in un programma di riforme: i Comuni furono invitati a mandare delegazioni a Napoli — dopo un po’ ci si vide costretti a ridurre a due il numero dei delegati, perché intere comunità si trasferivano nella capitale, con una rilevante presenza femminile — per esporre i loro problemi e gli «aggravij» imposti dai baroni. I deputati di ciascuna Università dovevano essere eletti in pubblico ed essere «persone a soddisfazione di tutto il popolo». Una certa solidarietà tra ceto civile e popolo minuto, con la frequente adesione del clero e, a volte, di aristocratici cittadini, si era sedimentata nelle battaglie precedenti. Soprattutto i Parlamenti locali favorirono in molti casi il passaggio del tumulto dal furore immediato all’azione politica. Tra le diverse città si costituirono anche delle leghe (come quella tra Cava, Sanseverino, Nocera, Montuori e Solofra) e si posero le premesse dei tentativi successivi di organizzazione generale del movimento rivoluzionario repubblicano. Nella prima fase della ribellione, la proclamazione di fedeltà alla monarchia equivaleva alla proposta di un nuovo accordo “costituzionale” in cui il “popolo” fosse riconosciuto parte non più marginale e subalterna ma essenziale alla nazione politica.
Quando, nell’autunno inoltrato, le contraddizioni divennero ormai non più componibili, apparve una Lettera di istruttione per formare la nuova Repubblica, un documento programmatico in cui i repubblicani delineavano il nuovo ordinamento costituzionale, con l’obiettivo di stabilire un nuovo equilibrio tra le diverse parti della società e tra la capitale e le province. La base del nuovo ordinamento dovevano essere le assemblee formate nelle province dai rappresentanti delle aristocrazie cittadine e dai rappresentanti del popolo eletti da città e villaggi in rapporto al numero di abitanti. Il principio della sovranità monarchica veniva messo sottosopra: alle assemblee provinciali, infatti, sarebbe spettato il compito di scegliere i deputati per la formazione del Senato, l’istituzione nazionale di rappresentanza e di governo dello Stato. L’indipendenza era la via verso la pace, o almeno per la fine del coinvolgimento in guerre a cui Napoli non era interessata, e verso la prosperità: pax et ubertas. E ancora, nell’ultimo tentativo di compromesso, prima che ogni cosa precipitasse, alla Consulta, che era divenuta il punto di riferimento politico dei repubblicani, fu discusso un nuovo progetto: esso stabiliva che la capitale e le principali città delle province eleggessero 30 senatori, in pari numero tra nobili e popolari, e che 20 fossero cambiati ogni anno; il governo doveva essere costituito da 10 rappresentanti, ai quali era affidato il compito di sovrintendere, oltre che alla giustizia criminale e civile, alla gestione del patrimonio pubblico, inteso come un vero e proprio “bene comune”, formato dai beni già appartenenti al re e ai nobili che rifiutavano l’adesione alla Repubblica e da quelli espropriati ai gesuiti. Era previsto che la presidenza di ognuno dei tre settori dell’amministrazione fosse affidata a due ministri, uno nobile e uno popolare, ed era escluso l’esercizio di titoli e privilegi nell’ambito del Senato. In quel momento, ormai il progetto era irrealizzabile e l’epilogo — com’è noto — fu ben diverso: il 5 aprile 1648 le truppe spagnole rientrarono in città. L’idea di un maggiore equilibrio all’interno della società, fra i cittadini e la Repubblica, e dei territori, fra il centro e la periferia, era il nucleo ideale che sarebbe rimasto come lascito.
«Per una rivoluzione non v’è oggetto più importante della scelta de’ municipi»
A questo lascito, ancora nel 1801[9], Vincenzo Cuoco nel suo Saggio storico riconoscerà vitalità: «La nazione napoletana ha i suoi comizi, e sono quei parlamenti che hanno tutte le nostre popolazioni; avanzi di antica sovranità, che la nostra nazione ha sempre difesi contro le usurpazioni dei baroni e del fisco. È per me un diletto ritrovarmi in taluno di questi parlamenti e vedervi un popolo intero riunito discutervi i suoi interessi, difendere i suoi diritti, sceglier le persone cui debba affidar le sue cose»[10]. Il 23 gennaio 1799 era stata proclamata la Repubblica Napoletana. Fu lo Championnet a ordinare al Comitato di legislazione (già incaricato di redigere l’atto costituzionale) di terminare i lavori il 21 marzo per poter in quel giorno proclamare «sotto gli auspici dell’Armata francese, vittoriosa e liberatrice, la sovranità del Popolo napoletano, l’atto di indipendenza della repubblica e il suo codice costituzionale». Poi lo Championnet fu richiamato e, subentratogli il Macdonald, il progetto di legge subì un rallentamento. La discussione ebbe inizio il 20 maggio. Il momento era ormai critico per la Repubblica e i dibattiti si svolgevano fra sempre maggiori difficoltà e continue interruzioni e aggiornamenti. Ancora l’1 giugno — secondo quanto si poteva leggere sulle pagine del «Monitore» di Eleonora Pimentel Fonseca — il Progetto continuava a essere oggetto di «varie metafisiche riflessioni» da parte della Commissione legislativa. Si era ormai alla vigilia della caduta della Repubblica e dell’intera costituzione rimase solo il progetto, che verrà stampato solo nel 1861[11]. Dei tre legislatori che vi lavorarono, Mario Pagano, nato a Brienza, in Basilicata, praticamente l’estensore del testo, al ritorno dei Borboni viene arrestato, condannato a morte e impiccato in piazza del Mercato il 29 ottobre 1799, insieme all’avvocato Giuseppe Logoteta di Reggio Calabria, mentre il prete giansenista Giuseppe Cestari, un napoletano, un radicale che sulla questione della feudalità proponeva l'abolizione del "vergognoso" giogo feudale escludendo qualsiasi indennizzo ai colpiti dal provvedimento, era già morto in un assalto dei sanfedisti o l’ultimo giorno della Repubblica — dichiarata decaduta l'8 luglio dal re Ferdinando IV. Durante i lavori preparatori, Mario Pagano, per mezzo del comune amico Vincenzo Russo, aveva fatto pervenire a Vincenzo Cuoco il progetto di Costituzione per averne un parere. E il Cuoco scrive delle lettere all’amico Vincenzo, in merito. Frammenti di quelle lettere diventeranno l’Appendice del suo Saggio storico sulla rivoluzione. La critica che il Cuoco muoveva al testo napoletano era in realtà rivolta al costituzionalismo rivoluzionario italiano nel suo complesso, i cui artefici — sosteneva il Cuoco — pervasi di esprit géométrique, avevano introdotto degli ordinamenti identici a quelli sperimentati in Francia senza tenere in minimo conto le esigenze concrete delle loro popolazioni, commettendo pertanto l’errore di vedere nelle costituzioni null’altro che una sovrastruttura da calare sul popolo, anziché concepirle quali il prodotto naturale e spontaneo della sua coscienza storica. Pertanto, pur non negando che il progetto costituzionale del Pagano fosse «migliore al certo delle costituzioni ligure, romana, cisalpina»[12],[,] il Cuoco lo giudicava comunque «troppo francese e troppo poco napoletano». Il giudizio secco e tagliente — è evidente a esempio l’influenza del dibattito costituzionale francese e americano sul pensiero del Pagano in tema di controllo di costituzionalità delle leggi, ma è interessante però notare come già nel 1783 (dunque ben prima della soluzione americana e delle proposte francesi), nei suoi Saggi politici venivano avanzate proposte innovative — non dà del tutto conto delle importanti differenze. Che è invece possibile riscontrare[13], a esempio nel diritto di resistenza all’oppressione (art. 9) che, presente nella Dichiarazione francese del 1793, mancava invece in quella del 1795; sul tema dell’educazione pubblica — la Costituzione termidoriana si limitava ad occuparsi della sola “istruzione”; sul potere legislativo ad un organo bicamerale, con un vero e proprio rovesciamento del rapporto fra i due rami del potere legislativo rispetto all’originario modello francese, attribuendo al Senato il potere d’iniziativa legislativa e di redazione dei testi di legge; sull’istituto della Censura (artt. 314-316), legato al tema dell’educazione pubblica, del tutto assente nella Costituzione del Direttorio; e infine sull’Eforato, organo che lo stesso Cuoco non poté fare a meno di definire «la parte più bella del Progetto del Pagano», con il compito di «custodia della Costituzione» — insomma una Corte Suprema, una Corte costituzionale. Anche nella proposta dell’Eforato, come d’altronde per quella della Censura, il Pagano immaginava un riferimento territoriale — rispettivamente: uno per ogni Cantone e uno per ogni Dipartimento della Repubblica. Eppure, sarà proprio l’elemento “verticista”, dirigista della sua forma di organizzazione dello Stato, mutuata dal giacobinismo francese, quello che il Cuoco metterà maggiormente a critica. La posizione del Cuoco — come già quella di tutti i partecipi della rivoluzione del 1647 — è che Napoli possa vantare [«cari avanzi degli altri tempi»] una persistenza di usi e costumi che ne hanno forgiato le istituzioni assembleari in indipendenza e equilibrio, dato che «le costituzioni sono simili alle vesti: è necessario che ogni individuo, che ogni età di ciascun individuo abbia la sua propria, la quale, se tu vorrai dare ad altri, starà male [...] Le costituzioni si debbono fare per gli uomini quali sono e quali eternamente saranno, pieni di vizi, pieni di errori; imperocché tanto è credibile che essi voglian deporre que’ loro costumi, che io reputo una seconda natura, per seguire le nostre istituzioni, che io credo arbitrarie e variabili, quanto sarebbe ragionevole un calzolaio che pretendesse accorciare il piede di colui cui avesse fatta corta una scarpa»[14]. Fino a dire: «Tante più ragioni mi trovo da credere che fondare la repubblica napolitana altro non sia che rimetter le cose nell’antico stato». La questione della municipalità, quindi, e di come intenderla, sarà il cuore della critica: «Io perdono ai francesi il loro sistema di municipalità: essi non ne avevano giammai avuto», mentre invece «senza proclami» basterebbe dire alla nazione napoletana che da ora in poi ciascuna popolazione potrà provvedere ai suoi interessi senza né baroni né fisco. «Ciascuna popolazione convocata in parlamento eleggerà i suoi municipi. Essi avranno il potere esecutivo delle popolazioni, saranno i principali agenti del governo, e dovranno render conto della loro condotta al governo ed alla popolazione. La loro carica durerà un anno. Con un’altra legge ne ordinerei la convocazione impreteribile in tutt’i quindici giorni». È verso questa devoluzione al territorio, piuttosto che a un’avocazione verso l’alto che guarda Cuoco: «Quante buone opere pubbliche noi avremmo, se più libero si fosse lasciato l’esercizio della loro volontà alle popolazioni? Ma da che si è posto un freno alle municipalità, si è raffreddato anche lo spirito pubblico: il governo ha preso cura di tutto; ma il governo, volendo tutto far solo, o non ha fatto nulla, o ha fatto tutto male». Ristabilire al centro dell’ordinamento il sistema municipale — il “territorio continentale” della Repubblica era stato diviso in 17 dipartimenti, e ogni dipartimento era diviso in cantoni e ogni cantone in comuni, e il Cuoco avrebbe desiderato un rappresentante per cantone — salverebbe anche da «mali infiniti», e qui Cuoco fa una proposta originale sulla riscossione delle tasse: «Una popolazione della Messapia non ha altro prodotto che l’olio, e deve aspettare il ricolto del mese di novembre; l’abitante dei piani della Daunia, pastore ed agricola, lo ha già nel mese di luglio; pastore ed agricola, l’abitatore delle fredde montagne dell’Apruzzo deve aspettare fino a settembre; l’agricoltore raccoglie in un giorno solo il frutto delle fatiche di un anno; il manifatturiere lo raccoglie ogni giorno; il commerciante aspetta il tempo delle fiere… non ti resta a far altro se non che imporre la somma dei tributo e farne la ripartizione sopra ciascuna popolazione, lasciando in loro balìa la scelta del modo di soddisfarla». E si spingerà fino a immaginare, per timore che troppa forza concentrata in un punto non possa che generare dispotismo, che «se la forza armata di una nazione deve assolutamente dipendere dal potere esecutivo, nella ripartizione di forza e di opinione consiste tutto il mirabile delle grandi legislazioni». E come esempio ricorderà: «Noi avevamo un’istituzione quasi ché simile ai nostri capodieci, istituzione corrotta, ma che intanto, riformata, potrebbe divenir ottima…»; erano i dieci consultori che stavano accanto all’Eletto del popolo, e uscivano da votazioni successive a cui prendevano parte i capi di famiglia di ciascuna delle ventinove Ottine in cui era divisa la città. E le Ottine, con i popolani che non intesero mai cedere le armi, erano state proprio il cuore organizzativo della rivoluzione del 1647 e della svolta repubblicana.
Appunti a mo’ di conclusione: «il sugo di tutta la storia»
1) Il tratto distintivo del potere decisionale che governa e ordina oggi le nostre vite, quello del denaro, del capitalismo finanziario dei fondi privati di investimento e dei fondi sovrani, è l’extraterritoralità. Lo scarto, la differenza tra il capitalismo produttivo e quello finanziario è uno scarto, una differenza spaziale. Non solo il capitalismo manchesteriano, e la sua versione renana, erano legati a un territorio — a una fabbrica, a una miniera, a una città, anzi costruiva territorio e luogo intorno a sé, da Wolfsburg a Detroit a Torino —, ma anche quello delle multinazionali, quello delle concentrazioni in una nazione e delle acquisizioni altrove, quello delle delocalizzazioni. Il capitalismo finanziario invece, se pure ha centri da cui irradia, da cui prende abbrivio, non ha un luogo centrale nel suo processo, non si delocalizza ovvero si decentra, è NO LUOGO. Il capitalismo delle merci era un’appropriazione di tempo, tendeva a ridurre il tempo disponibile sociale fuori di sé e del suo processo o a comprimere di intensità quello comprato; il capitalismo del denaro o finanziario è un’appropriazione di spazio, un allargamento degli spazi del suo processo, una estensione e un’estensività. La velocità operativa di alcuni algoritmi di matematica finanziaria che hanno compresso il tempo in modo inimmaginabile alla velocità del gesto e persino a quella del pensiero ha reso lo spazio un automatismo, proprio come il capitalismo delle merci aveva reso automatica la misurazione del tempo del lavoro. Potremmo definire l’extraterritorialità la costituzionalità dell’economia finanziaria — la si chiami globalizzazione o “i mercati finanziari” o com’altro. Purché questa accezione di extraterritorialità non sia intesa solo in senso sovranazionale, sovraterritoriale, sovrastatuale, cioè in senso solo addizionale, estensivo dei caratteri precedentemente precipui in un solo territorio — i mercati finanziari non sono una federazione delle borse e dei mercati nazionali —, bensì in senso nuovamente imperiale, di un nuovo dominio imperiale: Rule, Britannia! Rule the waves. E purché l’accezione di costituzionalità sia intesa non in senso normativo — come è stato per le costituzioni europee del dopoguerra, nella regolazione del conflitto tra capitale e lavoro — ma fondativo: il capitalismo finanziario non è anticostituzionale ma extracostituzionale; attraversa le costituzioni, materiali e formali, come attraversa i territori. Le costituzioni sono ancora formalmente legate ai territori, a regolare la produzione dei territori e i suoi conflitti; il capitalismo finanziario non è legato ai territori, non può esserlo per principio, per suo fondamento, e perciò non è legato alle loro costituzioni e alle regole dei loro conflitti. È indifferente ai territori e perciò anche alle sue costituzioni. Nel senso che le loro differenze vengono rese omogenee dal suo operare, e nel senso che il suo operare le rende omogenee. La diversificazione territoriale del capitalismo delle merci, dove giocava un proprio ruolo di adattamento, mediazione e compromesso la carta costituzionale, è ormai una trama lisa. Il rapporto tra territorio e capitalismo finanziario non è più mediato dalle costituzioni. Sta qui il suo principio di immunità, extra legem. Le costituzioni sono dominate dall’imperialità del capitalismo finanziario. È l’extraterritorialità la norma oscura e fondativa dell’emergenza e dell’eccezionalità. La sua extraterritorialità costringe e piega le costituzioni alla sospensione, all’emergenza e all’eccezionalità. L’interpretazione “stretta” fra nazione e costituzione dell’Ottocento, riversatasi in quella fra Stato e costituzione del Novecento, si è sfilacciata. La frattura del legame orizzontale, del circuito virtuoso fra rappresentanza politica e territorio, fra democrazia e territorio è evidente e consumata. Il rapporto tra capitalismo finanziario e territorio diventa così direttamente politico, senza mediazioni, con asimmetria: l’uno immune, nel suo agire, dalle costituzioni, legibus solutus; l’altro vincolato, impedito, nel suo agire, dalle norme, dalle leggi.
2) Di contro emerge una nuova consapevolezza del territorio. Essa assume spesso il senso di una «antica sovranità», come scriveva Cuoco, il principio ultimo di un diritto del territorio, di un diritto della comunità al territorio che trascende ogni forma costituita. La nuova coscienza territoriale si muove verso la destituzione dei poteri piuttosto che verso un nuovo pouvoir constituant. La provvisoria, effimera, azione di destituzione dei poteri — gli infeudamenti che si sono stratificati nei governi territoriali dell’impero, come in quello spagnolo intorno la metà del Seicento — si intende quasi un radicato, persistente processo di pouvoir destituant. Sollevarsi è levarsi di dosso la stratificazione dei poteri sul territorio, restituendolo alla sua semplicità. Il bonum humanum simpliciter, di cui parlava Giuseppe Dossetti[15], il bene comune, non sta in un qualche finalismo — è oggi — ma è declinato al plurale e devoluto ai territori. «Il sugo di tutta la storia», rovesciando quel che il Manzoni fa dire a Renzo per quelle gran cose che ci aveva imparato — «Ho imparato, diceva, a non mettermi ne’ tumulti: ho imparato a non predicare in piazza» —, è che l’eccezionalità va assunta persistentemente nei territori, e che la ricerca di altre regole può essere solo provvisoria, provisional, revocabile, ma la disobbedienza alle norme può essere solo permanente, costituita. Insomma, reinterpretando il titolo di questo breve saggio: la brevità delle costituzioni poggia sulla lunghezza dello spirito repubblicano.
3) In una celebre conferenza tenuta alla Sorbona nel 1882[16], Ernest Renan disse che «l’esistenza di una nazione (mi si perdoni la metafora) è un plebiscito di tutti i giorni, come l’esistenza dell’individuo è una affermazione perpetua di vita». Io direi, e senza bisogno di metafora, che l’esistenza di un territorio — una città, una valle, un’isola, una metropoli — è un plebiscito di tutti i giorni: è questo il cuore di ogni cittadinanza.
Nicotera, dicembre 2012
[1] M. Ruini, Relazione al Progetto di Costituzione della Repubblica italiana: http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/ddl/00Anc.pdf
[2] Sulle costituzioni preunitarie, vedi: A. Aquarone, M. D’Addio e G., Negri Le Costituzioni italiane, Edizioni Comunità, Milano, 1958.
[3] Carta del Carnaro 1920, Testo predisposto da Alceste de Ambris: http://www.dircost.unito.it/cs/docs/carnaro1920.htm
[4] Un importante progetto di ricerca, The Rise of Modern Constitutionalism, 1776 – 1849, Constitutions of the World from the late 18th Century to the Middle of the 19th Century Online, può consultarsi qui: http://www.modern-constitutions.de/
[5] Della rivoluzione napoletana del 1647 si è volgarizzata e tramandata, non senza interesse, una dimensione plebea e umorale. È merito, fra gli altri, del lavoro di Rosario Villari e in particolare del suo ultimo libro, Un sogno di libertà – Napoli nel declino di un Impero 1585–1648, Mondadori, Milano, 2012, averle restituito complessità, importanza, grandezza. A questo libro soprattutto faccio qui riferimento.
[6] P.L. Rovito, La rivoluzione costituzionale a Napoli (1647-1648), in «Rivista storica italiana», XCVIII (1986), pp. 376, 388, 397 segg., 403-413.
[7] N. Machiavelli, Discorsi sopra la Prima Deca di Tito Livio, Einaudi, Torino, 2000, pag. 90.
[8] ibidem, pp. 190–191.
[9] Del Saggio storico di Cuoco, esistono due edizioni, l’una del 1801 e l’altra del 1806. Sulle differenze e sulle motivazioni delle modifiche di Cuoco, rimando all’Introduzione di Pasquale Villani, cui qui si fa precipuo riferimento: V. Cuoco, Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli, BUR Rizzoli, Milano, 2009.
[10] V. Cuoco, op. cit., pag. 325.
[11] Il testo integrale si può leggere qui: Governo Provvisorio della Repubblica Napolitana, Costituzione napoletana del 1799: http://www.monitorenapoletano.it/sito/area-download/doc_view/42-costituzione-della-repubblica-partenopea-del-1799
[12] Tra il 1796 e il 1799, in tutta la penisola italiana sorsero, con il sostegno del Direttorio, governi repubblicani il cui assetto politico-istituzionale rifletteva quello della Francia post-termidoriana. Un elenco, con i testi, delle Costituzioni precedenti quella vigente si può trovare qui: http://www.dircost.unito.it/cs/paesi/italia.shtml
[13] Una puntuale disanima si trova in: V. Ferrari, Il progetto costituzionale della Repubblica napoletana del 1799: http://www.ichrpi.it/Ferrari06.html, sito della International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions (ICHRPI)
[14] V. Cuoco, op. cit., pp. 319 e segg.
[15] G. Dossetti, Funzioni e ordinamento dello stato moderno, Relazione tenuta da Giuseppe Dossetti a Roma il 12 novembre 1951 durante il III Convegno Nazionale di Studio dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani, ora reperibile qui: http://www.dossetti.com/dossetti/funzionieordinamento.html
[16] E. Renan, Che cos’è un nazione?, Donzelli, Roma, 1998.
pubblicato sulla rivista «Il Ponte», febbraio/marzo 2013 dedicato ai Beni comuni
|
 |
| [torna
su] |
 |
|
|