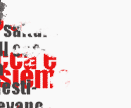|
|
|
01 Novembre 2011
Vent’anni fa, la storia di DeriveApprodi |

 Vent’anni fa stavamo attraversando il deserto. Non eravamo diretti verso la terra promessa, quella, semmai, era alle nostre spalle. Il deserto era tutt’intorno a noi, era abitato, sovrappopolato. Una civiltà era andata distrutta, una nuova specie umana emergeva dalle sue rovine, ma noi non riuscivamo a riconoscerne i volti, i corpi: tutto levigato, senza tracce né memoria. Solo noi eravamo pieni di cicatrici. Ma non ci eravamo salvati, eravamo i sommersi. Vent’anni fa stavamo attraversando il deserto. Non eravamo diretti verso la terra promessa, quella, semmai, era alle nostre spalle. Il deserto era tutt’intorno a noi, era abitato, sovrappopolato. Una civiltà era andata distrutta, una nuova specie umana emergeva dalle sue rovine, ma noi non riuscivamo a riconoscerne i volti, i corpi: tutto levigato, senza tracce né memoria. Solo noi eravamo pieni di cicatrici. Ma non ci eravamo salvati, eravamo i sommersi.
Era successo troppo.
Gli anni Ottanta erano stati l’apotesosi delle ideologie liberiste: il thatcherismo e il reaganismo avevano trionfato. In breve: la società non esiste, ci sono solo gli individui; i ricchi sono l’élite sociale e quelli che trainano, spendono e investono, e non vanno certo penalizzati, tassati, ma lasciati liberi di muoversi senza regole, lacci e lacciuoli; la collettività, lo Stato non può farsi carico di chi rimane indietro, ci penserà il mercato, e la disoccupazione e la povertà sono comunque endemiche; ci saranno opportunità e possibilità di arricchimento per tutti, se riusciamo a toglierci di dosso l’eredità di diritti e normative sul lavoro che pesano parassitariamente sulla mobilità del capitale e quindi sullo sviluppo. Questo era successo negli anni Ottanta, gli anni del ritorno dell’ideologia come arma letale, arma di distruzione di massa. L’occidente non può mettere ordine nel mondo, se non mette ordine in casa propria.
E il socialismo aveva dimostrato il suo fallimento in termini di utilità e razionalità: aveva preteso di offrire più sicurezze e meno sperperi, invece non funzionava, nonostante un’oppressione bestiale. Aveva dimostrato anche la sua irriformabilità; era condannato a ripetersi sempre uguale (disfunzionalità e oppressione: le disfunzionalità erano sempre colpa di un qualche permissivismo che andava spazzato via). Non c’erano alternative, solo il default. Il 1989 era stato il default del comunismo reale: a Mosca come a Pechino. Un default insanguinato. Ora scoppiavano le crisi a catena dentro il suo mondo, la Jugoslavia, anzitutto, la Cecenia, la Georgia.
Una doppia crisi – quella dello sviluppo e quella del progresso –, scoppiata negli anni Settanta e che investe contemporaneamente il capitalismo e il socialismo, cerca una risposta nell’azzeramento della storia. La storia finiva perché ricominciava all’indietro.
Insomma, era stato il tempo delle nuove e vecchie geo-ideologie: l’occidente era tornato ai fondamentali del mercato, l’utile, l’interesse individuale; e, prendeva consistenza, si espandeva l’ideologia della religione come guida politica, dopo la rivoluzione khomeinista: l’islam riscopriva il Corano – e le sue versioni – come interpretazione politica del mondo, come nuova soggettività storica. La Cina, come il Brasile, come l’India, possono profittare di questa crisi.
Quella che era rimasta stritolata era l’ideologia sociale, il comunismo, la geo-ideologia dell’est europeo e asiatico, del terzo mondo, dei paesi emergenti. Qui la storia finiva in un vicolo cieco.
Gli anni Novanta si trovano in questo passaggio. Ed è qui che prende corpo il clintonismo. Il clintonismo non c’entra niente con l’esperienza europea della socialdemocrazia, del riformismo laburista: questi dovevano far fronte all’incombenza del socialismo, quello sta dentro la crisi del capitalismo.
Il clintonismo (e Blair, Prodi, Schroeder, fino a Zapatero) è l’idea di poter governare il passaggio, di poter pragmaticamente fare fronte a quella crisi degli anni Settanta, la crisi del capitale: scarsa produzione, scarsa occupazione. E di poter acconciare in modo meno traumatico la svolta liberista. Il clintonismo è speculare alla svolta cinese, l’idea di poter accomodare la fine del socialismo in modo meno traumatico da quello sovietico.
Era questo il deserto. Alla fine degli anni Ottanta, ci ritroviamo nel deserto delle idee in occidente.
Nella teorizzazione della fine delle idee. Il conflitto si sposta dal lavoro (che ha subito la più grande ristrutturazione dall’introduzione ottocentesca delle macchine) e diventa questione marginale: la riduzione del lavoro diventa riduzione della sua soggettività politica; un andamento ciclico. Mentre l’attenzione torna tutta sulla geo-politica, sulla forza, sulla guerra e sulla pace. Anche il capitale si sposta dal conflitto – non solo con il lavoro ma anche con le nuove tecnologie – arrivando sulla finanza. La finanza è ancora appartata, poco visibile. Ma è qui che si gioca la globalizzazione. È qui, e non sulla mobilità delle merci o del lavoro – che già c’erano state nella commercializzazione mondiale dell’impero britannico e nelle nazioni-impero – la differenza sostanziale.
Il pensiero politico italiano è il più attrezzato di tutti. Dicono dipenda da una lunga tradizione. Io credo piuttosto dipenda solo dalla straordinaria contingenza degli anni Settanta. Come Lenin riuscì a trasformare un paese industrialmente arretrato – dove mai avrebbe dovuto esserci l’affermazione del proletariato industriale – nell’officina del bolscevismo, nel posto più avanzato della sperimentazione sociale di un ordine nuovo, così l’onda lunga del biennio ’68-69, fino al Settantasette, aveva trasformato il paese più cattolico del mondo nel posto della legislazione più avanzata in termini di divorzio e aborto, e di una tolleranza culturale e sessuale inimmaginabile altrove, il paese con il più forte partito comunista occidentale nel posto dove la critica ai suoi principi, ai suoi riferimenti, alle sue politiche era di massa ed era libertaria non reazionaria, il paese più malfermo nei fondamentali dell’economia e dove la distribuzione della ricchezza era ancora ferma al latifondo nel posto del benessere più diffuso e equo.
La dolce vita italiana era iniziata negli anni Settanta, quell’altra era una manfrina per pochi.
Ora, nel deserto c’era rimasto solo il pensiero politico.
A iosa, strabordante, eccedente. Ma sommerso.
Che succede quando hai un patrimonio teorico enorme ma non il tempo storico? Ti chiudi in convento e lo conservi.
Ne fai codici, digesti, pandette. Metti i monaci a lavorarci sopra, a arricchire il lascito con miniature e mappe e disegni.
Che succede quando hai una religione ma non i fedeli? Predichi ai passeri, sperando che un giorno acquisiscano la parola.
Questo erano le riviste degli anni Novanta. Questo era «Derive Approdi», come le altre. Codici miniati e prediche ai passeri.
Pochi altri ferventi monaci arrivavano, pronti a perpetuare il lavoro, ma le chiese restavano vuote.
Ci si passava l’un l’altro le profezie, come fossero terzine di Nostradamus capaci di indovinare gli accaduti. Era così. Tra le oscure righe, la profezia era chiarissima. Ma restava una pratica di iniziati. Di illuminati. Di massoni.
Poi gli anni Novanta finirono.
E finirono con Seattle.
I passeri arrivavano in stormo e facevano un gran baccano.
Nicotera, 1 novembre 2011 |
 |
| [torna
su] |
 |
|
|